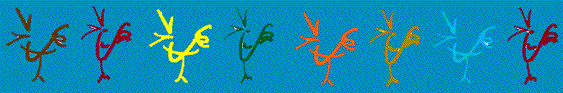tratto da “Pensare la plusdotazione. Verso una epistemologia della differenza”, lavori in corso
1. Una prassi
Il mio sviluppo teorico nel campo della plusdotazione si orienta con una prassi epistemologica che integra elementi di psicologia dello sviluppo, della pedagogia critica e filosofia dell’educazione.
Con una formazione psicologica, collego il paradigma tradizionale della plusdotazione (il più intelligente, il più sensibile, il più …) per abbracciare un approccio costruttivista, relazionale e contestuale del talento, orientato alla promozione del benessere e della crescita della persona.
Un vaso può essere riempito o meno.
Alla base del mio pensiero vi è innanzitutto una prospettiva costruttivista, secondo la quale lo sviluppo cognitivo e personale, a partire dalla dotazione innata, non è il semplice prodotto della dotazione innata, ma il risultato dell’interazione tra individuo, ambiente e relazioni educative. In questa visione, il talento non è qualcosa di statico e predeterminato, ma un potenziale in divenire, che può essere riconosciuto, alimentato o anche trascurato a seconda delle opportunità relazionali e didattiche offerte. Questo orientamento richiama le teorie socioculturali di Vygotskij, che vedono nell’ambiente e nella relazione educativa elementi fondanti dello sviluppo individuale.
Un altro fondamento epistemologico centrale è la visione relazionale e situata della plusdotazione. Evito una concezione dell’intelligenza come costrutto stabile, sottolineo invece che il talento emerge nel contesto educativo e nella qualità delle relazioni. Il riconoscimento da parte dell’adulto, la possibilità di esprimersi in ambienti significativi e la fiducia nello sguardo dell’altro sono elementi imprescindibili per l’attivazione del potenziale. Da questa prospettiva, l’identificazione della plusdotazione non può limitarsi a un punteggio di QI, ma deve fondarsi su un’osservazione qualitativa e contestualizzata del soggetto.
Inoltre nell’orizzonte della pedagogia critica, ponendo l’accento sulla necessità di una scuola inclusiva, democratica e attenta ai vissuti degli studenti, critico onestamente la strutturazione vetusta della scuola. Vedasi il mio concetto: “Una barriera sistemica alla realizzazione dell’alto potenziale”.
Infine, sul piano epistemologico, mi allontano al riduzionismo positivista e alla gerarchizzazione dei livelli cognitivi tipico della psicometria tradizionale, che riduce la complessità della persona a misurazioni standardizzate.
2. complessità
La mia proposta si fonda invece su un’epistemologia della complessità che valorizza la comprensione, il dialogo e la soggettività dell’esperienza.
In sintesi, cerco di fondare il mio approccio su un insieme coerente di riferimenti epistemologici che mettono al centro la persona nella sua interezza, riconoscendo il valore del contesto, della relazione educativa e del processo formativo. Con questa concetto suggerisco un’alternativa significativa ai modelli standardizzati e normativi della plusdotazione, aprendo la strada a pratiche educative più inclusive, critiche e umanamente sensibili.
La mia idea è che la plusdotazione non sia riducibile solo al un quoziente intellettivo, ma vada compresa come una modalità particolare di funzionamento mentale. In qualche maniera immagino un modello operativo psicologico della plusdotazione.
leggi su: Pensare la plusdotazione. Verso una epistemologia della differenza