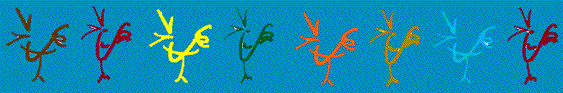Giovanni Galli
Tratto da: APC: quaderni locali, numero 2, pagine 16-17, zetapiesse edizioni, Locarno, settembre 2025 Tutti i diritti riservati.
Nel dibattito pedagogico dedicato all’alto potenziale cognitivo ricorrono due strategie quasi canoniche, quasi un mantra: arricchimento e accelerazione. Sono strategie utili, indubbiamente: mantengono vivo il desiderio di conoscere, prevengono la noia, permettono al bambino o al ragazzo plusdotato di muoversi in un ambiente più adeguato al suo ritmo di apprendimento.
Eppure, merita una riflessione, vale la pena fermarsi un momento.
Chiediamoci se davvero il plusdotato debba per forza incontrare “altri come lui”, o se debba accumulare continuamente nuove conoscenze. Perché farlo, e fino a che punto?
Il pensiero che propongo in queste righe è che queste strategie, pur necessarie, essenziali ed utili, non bastino a toccare il punto essenziale del plusdotato.
C’è un punto in cui l’arricchimento si trasforma in saturazione e l’accelerazione in mera fuga in avanti. L’idea implicita — spesso non dichiarata — è che il plusdotato abbia bisogno di ulteriori conoscenze, ulteriori stimoli, ulteriori complessità. Come se il problema fosse risolto con una carezza di materiale cognitivo.
Ma la domanda da porsi è più radicale: a che pro? Quale l’obiettivo?
La conoscenza è nutrimento, sì, ma può anche diventare un surrogato, un riempitivo: imparare per non sentire il vuoto, accumulare per non pensarsi, fare per non incontrare l’altro.
Prevale allor l’illusione dell’“ancora di più”: piu lezioni complesse, piu informazioni enciclopediche, più “gruppi dell’eccellenza”, eccetera.
Qui entra in gioco ciò che definisco Ricerca della Risonanza: il bisogno, profondamente umano, di trovare un Altro che non sia semplicemente “simile” o “al pari”, ma capace di entrare in vibrazione.
Quello che chiama “Ricerca della Risonanza” rimanda a un movimento più profondo: il bisogno di trovare un Altro costituente, non nel senso di un pari per livello cognitivo, ma nel senso di un interlocutore capace di rispondere, vibrare, entrare in una relazione che generi senso.
Non serve quindi che l’Altro sia “plusdotato”.
Serve che sia riconoscente, nel senso etimologico: che sappia riconoscere ciò che accade nell’incontro, e rispondervi. Un insegnante, un adulto, un coetaneo: chiunque sappia offrire uno spazio in cui le idee non solo si accumulano, ma si trasformano perché incontrano un’eco.
Per questo l’arricchimento e l’accelerazione, da soli, possono diventare quasi un rumore di fondo: tanta stimolazione, poca risonanza.
L’Altro costituente non amplifica il talento: lo rende possibile.
È l’adulto — insegnante, educatore, mentore — che non si limita a somministrare conoscenze, ma offre uno spazio in cui il pensiero prende forma perché trova eco, confine, dialogo. È il coetaneo che, anche senza particolari abilità cognitive, è disposto a stare nel gioco delle idee. È chiunque sappia generare un incontro che non sia soltanto informativo, ma trasformativo.
L’apprendimento vero avviene quando il soggetto, specchiandosi in un altro, avverte una vibrazione di senso. Non quando fa di più, ma quando qualcosa risuona.
Nella risonanza il pensiero non è più solo un “tanto”, ma diventa abitato. Un pensiero che si sente guardato, accolto, sfidato in modo generativo. Lì nasce davvero l’apprendimento significativo. Lì il plusdotato non si limita a “fare di più”, ma a costruire se stesso.
E forse è questo “Altro costituente” che sto cercando di delineare: non un contenuto, non un talento speculare, ma una presenza capace di attivare quella vibrazione che fa sentire vivi e pensanti allo stesso tempo.
Riscoprire la risonanza significa sottrarre l’alto potenziale al paradigma prestativo.
Significa ricordare che la crescita intellettuale non procede solo per accumulo, ma per incontri. Che lo sviluppo non è una corsa a ostacoli, ma una trama di relazioni significative che permettono alla curiosità di maturare e al talento di incarnarsi in una forma di vita.
L’obiettivo non è “potenziare” il plusdotato, ma offrirgli un contesto in cui possa sentirsi pensato mentre pensa.
Nota: l’immagine è “Zwei Männer in Betrachtung des Mondes”, Caspar David Friedrich, 1819-20.
tutti i diritti riservati