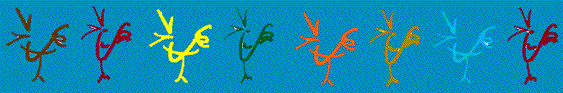François Brune
Comincia a dare qualche segno d’affaticamento l’insidiosa macchina di propaganda qual’é la pubblicità? Radio e televisione, confrontate con un calo dell’udienza, devono agire con astuzia. Astuzia per far ingozzare agli ascoltatori quei “messaggi” che, senza tregua, celebrano l’ordine di coloro che decidono (“décideurs”) e celebrano la felicità del consumo inutile.
Al di là della manipolazione e del disprezzo la pubblicità non svela, innanzitutto, una filosofia cinica che ambisce a trasformare il mondo in mercanzia?
Le elezioni passano, la pubblicità dimora, risiede, rimane. Le promesse politiche si alternano allegramente sulla superficie degli avvenimenti: il sistema di propaganda commerciale, lui, continua instancabilmente a modellare in profondità l’immaginario del pubblico, ogni giorno e in ogni luogo.
Non é il principio della “pubblicità”, nel senso originale della parola, che é messo in causa 1. E’ la realtà di un fenomeno sociale divenuto ipertrofico, che diffonde in permanenza ciò che bisogna ben riconoscere come una ideologia dominante e quindi chiamare come tale; e ciò non spiaccia agli euforici della modernità che desiderano vederci solamente un gioco senza posta in gioco.
A ogni forma d’ideologia dominate possono essere opposte due analisi critiche; la prima, stigmatizza la natura più o meno pericolosa della “visione del mondo” che essa costituisce: la seconda, sono l’esercizio stesso e i metodi abusivi del suo dominio. Sta a questi due livelli di critica denunciare la violenza di questo sistema.
Dall’origine i grandi tratti dell’ideologia pubblicitaria non hanno cambiato. Attraverso la loro apparente diversità, tutte le pubblicità celebrano i loro eroi. La mercanzia é il centro é il senso della vita; il mercato (super o iper) é il suo tempio obbligato.
Il messaggio costantemente ripetuto é chiaro: il consumo risolve tutti i problemi. Tutte le dimensioni dell’essere: corpo, cuore, spirito, possono trovarsi nel prodotto.
Le marche ci forniscono una identità professionale, “Ma crème, c’est tout moi” (“La mia crema, é tutto per me”, traduzione letterale di una pubblicità francese). I mercanti (e la dinamica capitalista che servono) creano una istanza assistenziale permanente al servizio della collettività.
Il sogno stesso si compra, poiché ci viene venduto. La felicità costituisce infine una somma di piaceri immediati, da programmare dalla mattina sino alla sera. Non ci sono ragioni per porci problemi metafisici; tutto ci viene risolto in anticipo. L’esistenza ha uno scopo infinitesimamente semplice: é sufficiente di “croquer dans la vie” (traduzione letterale “sgranocchiare nella vita” ) preferibilmente “à pleines dents” (traduzione letterale: “a pieni denti”, gioco di parole che riprende il “a piene mani”). L’uomo abbronzato retro-verso é l’ideale del ‘Io valevole per ognuno. Messaggio perfettamente compreso da una liceale che scriveva: “Alla televisione, fortunatamente, abbiamo la pubblicità che ci semplifica la vita” …
Una strana terapia sociale
Questa filosofia altamente idealista si completa con alcuni tratti ripetutamente denunciati. Tratti più che mai presenti: l’eterna celebrazione del nuovo (che squalifica ipso facto ogni passato), la pseudo-liberazione dei desideri (subito asserviti alla pulsione d’acquisto), la chiamata terrorizzante al consenso (allineatevi all’avvenimento prodotto: é la vostra epoca), l’insensatezza conviviale (forza, cedete e raggiungete l’euforia collettiva) e, più generalmente, la vampirizzazione di tutti i temi alla moda della vita sociale, culturale o politica 2.
La visione riduttrice delle pubblicità non si limita al contenuto. Queste modellano, pure, grazie al loro linguaggio, i modi di pensare delle giovani generazioni. Il discorso pubblicitario coltiva una retorica dell’associazione secondo la quale qualsiasi prodotto può essere rilegato a qualsiasi immagine: ogni realtà può essere così manipolata; ogni “valore” può essere ricuperato, poi ridotto a dei “segni” consumabili. Una tale “logica” può sboccare sulla perversione dell’idea stessa di valore, quando si vede per esempio l’etica o la bellezza dello sport deliberatamente associata alla celebrazione di bevande alcoliche 3. I film pubblicitari, impegnati a far di ogni prodotto uno spettacolo, contribuiscono a rinforzare la confusione del bambino tra mondo e immagine; l’evidenza é il visibile. Il ritmo caotico degli spot, giocando dei sofismi dell’immagine e del montaggio, abitua i più piccoli a vivere la loro relazione con le cose sotto forma dell’adesione-riflesso. Il linguaggio pubblicitario s’ingegna così a ritardare la lenta edificazione della ragione critica. Sotto pretesto della seduzione e della poesia, la pubblicità attuale é un operatore di de-strutturazione mentale.
Questa de-realizzazione del mondo, che si dà un alibi di creare un “immaginario”, ignora deliberatamente la realtà della crisi. Avremmo potuto credere che la disoccupazione, l’esclusione, la povertà avrebbero frenato l’esibizione del discorso pubblicitario e avrebbe fatto tacere le sirene del sovraconsumo. Non é così. Cosa importa la “frattura” sociale, poiché ci si indirizza alla maggioranza benestante. Cosa importa se centinaia di migliaia d’individui sono forzati alla contemplazione quotidiana dei modelli d’esistenza che sono inaccessibili a loro! Questa violenza quotidiana non ci emoziona. Dopo tutto, perché si rifiuterebbe ai poveri di sognare ciò che i ricchi possiedono: non é forse quanto si fa nei paesi del terzo mondo 4?
All’ordine economico, che ha come effetto di escludere i poveri, s’aggiunge oramai l’ordine pubblicitario, che ha la funzione di farceli dimenticare. Del resto, qualche anno or sono, un pubblicista di nomea spiegava che: “più gli individui sono attenti alle pubblicità, più negano la crisi e i suoi aspetti strutturali. Da lì poi, ritardano e arrivano ad evitare il duro incontro con le realtà quotidiane” 5. Terapia ammirevole! Schema alla moda nell’affrontare i problemi, con la fuga dalla realtà come per le droghe!
Se la pubblicità restasse localizzata nel suo proprio terreno (ad esempio all’interno dei centri commerciali), l’uomo onesto la troverebbe pure tollerabile. Ma essa persegue senza fine la propria espansione, “fuori dal suo campo economico specifico”, rispondendo ai rimproveri della sua saturazione … con una super saturazione! Il discorso pubblicitario non é solamente totalitario perché pretende di rinchiudere tutta la vita umana nel consumo di mercanzie, lo é ben più ancora perché tenta di sottomettere al suo controllo l’insieme della città, eludendo le resistenze che non può forzare, occupando tutti gli spazi di libertà, giocando ancor più sulla passività che la seduzione e, per finire, usando questa violenza sottile che non é certo la minore: la violenza istituzionale.
La pubblicità si é istituzionalizzata: é “legittima”, é “naturale”, la respiriamo come l’aria stessa nelle città e nei media; le sue insegne, i suoi cartelloni, passati dal centro alle periferie urbane, abbelliscono graziosamente le nostre campagne … Questo imperialismo, denunciato a più riprese, non appare nemmeno più tale agli occhi di coloro che colonizza 6. Guardate i suoi straripamenti alla televisione: non si discute più il numero degli spot giornalieri, si discute ora sul numero dei “minuti in un’ora” che hanno diritto le pubblicità. Cosa é normale? ci si domanda: undici minuti? tredici minuti? quindici minuti? Trattando del “saucissonnage” dei film (traduzione letterale “salumaggio”, “affettatura” dei film), é sul “secondo” taglio che le catene televisive private sono passate all’assalto. C’è un dibattito, certo; ma non é mai per deplorare la violenza per effrazione che vien realizzata sia alle opere piratate che alla coscienza intrappolata degli spettatori. Il dibattito é solo per discutere la suddivisione delicata di una manna pubblicitaria non estensibile. La salvezza del gregge non si mantiene, per ora, che alla lotta fra i lupi.
Quale cittadino osa ancora meravigliarsi dell’ipertrofia dell’ideologia commerciale, che trasuda da tutti i suoi pori dei programmi televisivi? Le emissioni sponsorizzate a sazietà, i prodotti e le marche legate alle consacrazioni dei campioni, l’ondata di stelle che si vendono, il consenso sulla “pubblicultura” che celebra l’arte di manipolare le masse, i dibattiti stessi su alcune campagne indecenti (il quale abuso cauziona immediatamente la legittimità delle altre) … tutto concorre a consacrare la potenza oppressiva del sistema.
L’onnipresenza quantitativa del fenomeno pubblicitario comporta un cambiamento qualitativo rispetto il modo d’imporre i suoi propri modelli. Questo discorso dominate non dice più: “fate così”; dice: “tutti fanno così”. L’ingiunzione quotidiana non é: “ecco ciò che tu devi essere”, ma: “ecco ciò che tu sei”. Il modo indicativo si rivela allora molto più insidioso che il modo imperativo. Basta che le medesime immagini, i medesimi consumi, le medesime fonti si propaghino “nel quadro mediatico-pubblicitario” affinché, subito dopo, il pubblico le riceva come regnanti, e dunque seguite. L’onnipresenza del prodotto e dei segni crea l’illusione: di una condivisione democratica e di un consenso ideologico. La banalizzazione diventa la forma moderna della normatività. Non si scappa a dei modo di vita che sembrano già i nostri. Il più pericoloso dei modelli é quello che gioca allo specchio: nessuno potrà allora manifestare la propria differenza.
Adesso i nostri pubblicitari, giustamente, usano ed abusano del sofisma dello specchio per declamare la loro neutralità. Non condizionano, dicono, rispecchiamo (nel senso che fanno un riflesso, una rispecchiarsi), dicono. Non ammettono che riflettono un poco per condizionare molto.
La loro tecnica in effetti si sviluppa in tre tempi: fotografare alcuni aspetti reali dell’individuo o alcune tendenze del pubblico; selezionare, fra questi tratti, ciò che può accordarsi con l’ideologia del consumo; amplificare allora, all’intenzione dell’insieme del pubblico, i modelli o gli stili di vita così costituiti.
La loro costante manipolazione consiste così, con un rispecchiamento selettivo, nel produrre un massiccio condizionamento. Questa gigantesca operazione sociale riesce altrettanto meglio in quanto non si vede opporre alcun reale contro-potere istituzionale.
Se, in effetti, c’è a livello puramente commerciale, una difesa dei consumatori contro alcune pubblicità, non esiste il diritto di una risposta che si situi a livello ideologico. Non c’è spazio mediatico per un discorso critico. Nessuno andrà a richiedere sullo piccolo schermo 10 minuti in ogni ora per esprimere il suo disaccordo sui modelli d’esistenza spronati dalla pubblicità. Ne la donna maltrattata nell’immagine che si dà di lei, né il bambino frustrato dall’acquisto che non ha mantenuto le sue promesse, né il lavoratore insultato dal ricupero caricaturale della sua immagine, né l’umanista che vede deturpare i valori nei quali crede, possono denunciare ad alta voce la violenza morale che gli vien loro fatta. la resistenza all’ideologia pubblicitaria non può seguire che la via della protesta privata, nella semi clandestinità 7.
Distanti dall’ammettere le resistenze critiche del cittadino normale, l’istituzione pubblicitaria opera diligentemente un ricatto sull’anormalità che colpisce d’ostracismo i “pubblifobi” 8. Essa spinge coloro la raggiungono (l’istituzione pubblicitaria) a rigettare coloro che si lamentano della pubblicità, tendendo con ciò, come ogni sistema totalitario, a trasformare le vittime in boia. Ogni individuo che emette dei dubbi é sospettato d’arcaismo. Parlare di condizionamento, di mercantilizzazione dell’immaginario, significa passare come depositari di una ideologia marxista superata. L’individuo veramente “evoluto” deve nel medesimo stesso tempo raggiungere la massa (supposto “pubblicitafila”) e ridere dei marginali (supposti retrogradi). Alcuni filosofi “post-moderni” sostengono con i loro sofismi questa posizione, tanto credono loro stessi di venire esclusi dalla modernità 9.
Questo rifiuto di ogni contro-potere trionfa in un’utima proibizione, in un ultimo ricatto: osare attaccare il fenomeno pubblicitario, ci si obietta, significa favorire la disoccupazione e frenare il consumo. Come se la stgnazione del consumo non fosse prima di tutto legata al poter d’acquisto! Come se, nella società a due velocità, la salute del povero fosse direttamente legata alla bulimia del ricco. Come se l’impasse nella quale dovrebbero impeganrsi le nostre società consitesse ad alienarsi culturalmente per sopravvivere economicamente
Note
1)Nella sua prima accezione, la pubblicità designa il fatto di far conoscere al pubblico ciò che ha un interesse pubblico (che si tratti di dibattiti, opere o prodotti). Questo senso unicamente informativo non ha evidentemente più nulla a che vedere con l’ampiezza attuale del fenomeno pubblicitario. torna al testo
2) Cfr. Emmanuel Souchier, “Publicité et politique”, Le Monde diplomatique, dicembre 1994. torna al testo
3) Les marchands de mort – par le tabac ou par l’alcool -ne désarment pas, on le sait, contre la loi Evin qui freine leur publicité (notamment dans le cadre des retransmissions sportives). Le mouvement Alliance pour la santé a dû récemment dénoncer le “complot des cigarettiers”, en rappelant que “la publicité viole la conscience des plus jeunes et des plus démunis” (Le Monde, 1er juin 1995). torna al testo
4)Cfr. François Brune, “L’annonce faite au tiers-monde”, Le Monde diplomatique, maggio 1988. torna al testo
5) Bernard Brochant, dans sa préface au livre de B. Cathelat, Publicité et Société, Payot, Paris, 1987. torna al testo
6) Cfr. François Brune, “De l’impérialisme publicitaire”, Le Monde diplomatique, gennaio 1986. torna al testo
7) Ceux qui désirent sortir de la clandestinité peuvent rejoindre le mouvement Résistance à l’agression publicitaire: 61, rue Victor-Hugo, 93500 Pantin. Tél. (1) 46-03-59-92. torna al testo
8) Le mot “publiphobe” provient, on le sait, d’une campagne lancée par la profession publicitaire, au début des années 70, pour ridiculiser ceux qui tiennent trop à leur liberté d’esprit … torna al testo
9) Cfr. gli esempi citati da Jacques Blociszewski, “La publicité, culture de notre temps?”, in Manière de voir, n° 19. torna al testo