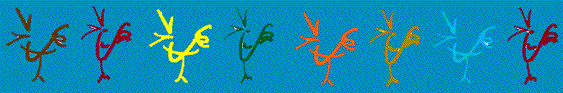Giovanni Galli, psicologo, psicopedagogista, specializzato in plusdotazione/APC
tutti i diritti riservati
I genitori di bambini APC si trovano spesso a gestire ragionamenti complessi e bisogni unici che differiscono notevolmente da quelli dei coetanei, rendendo indispensabile un supporto mirato.
Parallelamente, gli insegnanti incontrano difficoltà nel riconoscere e supportare adeguatamente questi allievi, vuoi a causa di una carenza di formazione specifica e di informazioni aggiornate, ma vuoi per la stessa strutturazione della scuola.
La lacuna formativa può portare a incomprensioni, frustrazione e, in ultima analisi, all’emarginazione degli studenti APC nel contesto scolastico.
La strutturazione odierna scolastica, l’istituzione scolastica, rimane per il momento ancorata a modelli educativi tradizionali, rigidi e standardizzati, che non tengono conto delle differenze neuro cognitive e dei bisogni formativi dei bambini plusdotati. E nemmeno tiene ancora conto delle sfide che pongono l’informatizzazione e oggi l’intelligenza artificiale.
I bambini plusdotati, con il loro stile cognitivo visuo-spaziale, divergente, intuitivo e gestaltico rischiano di sentirsi compressi se non possono procedere ed utilizzare le proprie modalità di funzionamento.
Lo stile cognitivo visuo-spaziale, divergente e analogico entra spesso in attrito con i metodi di insegnamento abituali, perché si fonda su modalità di pensiero che la scuola tradizionale raramente riconosce o valorizza.
Chi ragiona in modo visuo-spaziale tende a cogliere la globalità di un fenomeno attraverso immagini mentali, mappe concettuali, rappresentazioni grafiche e connessioni simultanee. La scuola, invece, propone quasi sempre un approccio verbale e sequenziale, che richiede di scomporre i problemi in passaggi lineari, spesso lenti e dettagliati. Per il bambino questo significa sentirsi obbligato a “smontare” un’intuizione già chiara, rallentando il ritmo del suo pensiero per adattarlo al passo imposto dal curricolo.
Lo stesso vale per il pensiero divergente: la scuola cerca una risposta unica e prestabilita, quella che coincide con il manuale o con la soluzione standard dell’insegnante. Ma chi è portatore di uno stile divergente produce naturalmente molteplici alternative, esplora strade laterali, formula ipotesi creative. Questo non solo non viene incoraggiato, ma talvolta è etichettato come “fuori tema” o “disattenzione”. In realtà, ciò che appare come dispersione è un arricchimento, un’apertura che va oltre i confini ristretti della didattica convergente.
Il pensiero analogico, poi, opera per associazioni, metafore, parallelismi tra campi apparentemente lontani. È un modo rapido ed efficace per trovare scorciatoie cognitive. La scuola richiede invece il rigore del procedimento logico-deduttivo, passo dopo passo, come se ogni intuizione dovesse essere giustificata in termini canonici. Ne deriva che lo studente plusdotato si sente spesso non compreso: ciò che per lui è una costruzione di senso immediata, per l’insegnante diventa un percorso “sbagliato” perché non aderente al metodo formale.
In breve, lo stile visuo-spaziale, divergente e analogico procede con una rapidità globale, che salta i passaggi ridondanti e integra diversi livelli di informazione. La scuola, invece, procede con programmata frammentazione del curricolo, produce padronanza algoritmica: esercizi ripetitivi, materie isolate, richieste uniformi per tutti. È qui che nasce lo scarto: laddove il bambino coglie connessioni interdisciplinari e propone soluzioni fuori dagli schemi, l’istituzione scolastica tende a percepire una deviazione dal percorso, e quindi a contenerla.
La scuola, così, appare non solo lenta, ma anche miopica rispetto ai nuovi processi cognitivi, che i mezzi informatici hanno introdotto e che i giovani APC ci indicano (per approfondire vedasi “Cosa ci insegna l’Alto Potenziale Cognitivo: Dal Big Bang ai vestiti nuovi dell’imperatore”). In breve, lo stile visuo-spaziale, divergente e analogico procede con una rapidità globale, che salta i passaggi ridondanti e integra diversi livelli di informazione. La scuola, invece, procede con programmata frammentazione del curricolo, produce padronanza algoritmica: esercizi ripetitivi, materie isolate, richieste uniformi per tutti. È qui che nasce lo scarto: laddove il bambino coglie connessioni interdisciplinari e propone soluzioni fuori dagli schemi, l’istituzione scolastica tende a percepire una deviazione dal percorso, e quindi a contenerla.
La scuola, così, appare non solo lenta, ma anche miopica rispetto ai nuovi processi cognitivi, che i mezzi informatici hanno introdotto e che i giovani APC ci indicano (per approfondire vedasi “Cosa ci insegna l’Alto Potenziale Cognitivo: Dal Big Bang ai vestiti nuovi dell’imperatore”).
Un tempo, la scuola (insieme al maestro, al prete, al sindaco) costituiva il fulcro della comunità, veicolando valori, identità e sapere nelle dinamiche di socializzazione secondaria. Oggi, a fronte dei nuovi mezzi di comunicazione, questa centralità è sempre più problematica
Gli studenti plusdotati (apc, alto potenziale cognitivo) reagiscono con sensibilità amplificata a questo contesto: sono come antenne, percependo con maggiore chiarezza quanto la scuola sia rimasta “museale”, statica e distante dalle esigenze dell’apprendimento contemporaneo.
Un’origine del problema è che, la scuola è tutt’ora pensata come istituzione che conserva e tramanda, più che come luogo che innova. Oltretutto ha un compito essenziale ed irrinunciabile: quello dell’apprendimento e padronanza degli algoritmi, ma i processi cognitivi dei ragazzi (non solo plusdotati) sono cambiati con gli strumenti digitali: si pensi al pensiero reticolare, al multitasking, all’immaginario visivo.
Negli ultimi decenni, con lo sviluppo tecnologico informatico stiamo assistendo a un vero e proprio cambio nello stile e nel funzionamento cognitivo degli studenti.
Nella trasmissione del sapere, conformemente alle necessità storico-culturali, la scuola, si è sempre fondata su strumenti sequenziali, come la lettura e la scrittura, che seguono un ordine lineare e cumulativo: prima una lettera, poi una parola, poi una frase. Questo approccio favorisce il pensiero analitico, la logica deduttiva, la capacità di concentrazione su flussi progressivi di informazioni.
Oggi, tuttavia, lo sviluppo tecnologico e la diffusione di nuovi linguaggi comunicativi stanno spostando progressivamente l’asse verso un funzionamento visuo-spaziale, multisensoriale e reticolare. Video, tutorial, documentari, infografiche interattive e ambienti digitali stimolano forme di apprendimento non più strettamente sequenziali, ma globali e simultanee. L’informazione viene colta come insieme visivo, come “mappa”, e non come catena lineare di elementi. In altre parole, il pensiero si orienta più alla sintesi percettiva e alle connessioni reticolari che non solo alla concatenazione progressiva. Oltretutto possiamo anche parlare di approccio multisensoriale in quanto che i processi sequenziali convivono con quelli visuo-percettivi, il testo scritto con le immagini, con le musiche, con i filmati.
Questo cambiamento non riguarda solo gli strumenti di trasmissione del sapere, ma anche il funzionamento cognitivo degli allievi:
- i processi attentivi diventano più multifocali, capaci di saltare da un contenuto all’altro;
- il pensiero si organizza in forma analogica e associativa, più che puramente logico-sequenziale;
- cresce la capacità di riconoscere pattern visivi e di navigare in ambienti complessi, mentre diminuisce la tolleranza verso processi troppo lenti e lineari.
La scuola si trova quindi di fronte a una sfida cruciale: continuare a garantire competenze sequenziali (lettura, scrittura, ragionamento logico), che restano fondamentali, senza però ignorare lo sviluppo del funzionamento visuo-spaziale. Anzi, deve imparare a integrare i due registri, costruendo ponti tra la logica lineare del testo scritto e la ricchezza immediata delle rappresentazioni visive.
Per gli studenti plusdotati questa tensione è ancora più evidente: molti di loro manifestano uno stile cognitivo fortemente visuo-spaziale, divergente e creativo, che rischia di scontrarsi con metodi di insegnamento rigidamente sequenziali. In questi casi, l’uso di strumenti visivi (mappe concettuali, schemi dinamici, simulazioni, video interattivi) non è una facilitazione “ulteriore”, ma un vero e proprio pozzo culturale storico di espressione e apprendimento.
In sintesi: siamo passati da una scuola fondata sull’“architettura lineare” a una società che stimola un “funzionamento reticolare visivo”. Il compito della scuola non è quello di scegliere tra i due, ma di fiondarsi nella modernità: custodire le abilità sequenziali e, al tempo stesso, valorizzare i nuovi stili visuo-spaziali, così da offrire agli studenti – e ai plusdotati in particolare – un ambiente di apprendimento all’altezza della complessità contemporanea.
Sonlert, 1° settembre 2025
Giovanni Galli, tutti i diritti riservati