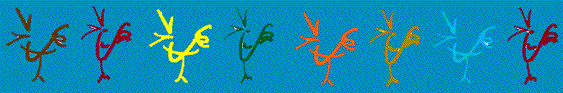Tazio Manzocchi
1. Con l’economia della globalizzazione si produce sempre di più con sempre meno lavoratori: la disoccupazione è un dato strutturale che coincide con un’elevata produttività determinata dall’aumento di intensità del lavoro e dai processi di precarizzazione. Per far funzionare un’economia in cui i settori trainanti sono costituiti da microelettronica, software e computer, telecomunicazioni, macchine utensili e robotica, biotecnologie, scienza di materiali, produzione di immagine, si ritiene che sia sufficiente, nella ripartizione delle attività lavorative, circa un 20% di analisti simbolici, un’élite nella quale si possono tra gli altri annoverare avvocati, professori universitari, ricercatori, specialisti della società dello spettacolo, “progettisti delle ricerche sul prodotto”, “coordinatori nella strategia dei sistemi”, “consulenti nella politica delle risorse”. Il rimanente 80% delle attività lavorative connesse alla nuova economia si compone in gran parte di servizi ripetitivi e di servizi interpersonali diretti. Al di fuori coloro che ormai solo a età inoltrata riescono ad accedere al circuito produttivo, coloro che ne vengono esclusi precocemente, coloro che vi accedono solo per intervalli di tempo ridotti e discontinui, i disoccupati tout court.
2. Consentire che dentro la scuola possa convenientemente realizzarsi il drenaggio di quel 20% di aspiranti ai posti di comando dell’economia e della società significa che occorre tenere a bada i predestinati all’esclusione, significa “gestire” l’esclusione di coloro che a scuola sono imputati di non ascoltare e di non imparare più niente.
Una scuola che priva la maggior parte dei suoi allievi di un adeguato accesso alla conoscenza è, etimologicamente, una scuola privata. L’esito paradossale della votazione popolare con la quale si è voluto conservare all’Ente pubblico il monopolio dell’istruzione è stato in realtà il conferimento di un nulla osta all’avvio di una silenziosa privatizzazione dell’accesso all’istruzione, una clandestina forma di privatizzazione della scuola pubblica dall’interno sotto le mentite spoglie di una scuola che continua a pretendersi pubblica. Estremo approdo della rinuncia ad accreditare l’illusione che la scuola possa farsi strumento di promozione sociale e di attenuazione delle disuguaglianze.
3. Prioritario diventa allora tener quieti i candidati all’esclusione scolastica e, in prospettiva, sociale. Gli esclusi non devono accorgersi di essere tali e per disinnescare potenziali esplosioni di aggressività vanno sedati procedendo al massiccio ricorso nelle strategie didattiche ad animazioni di ogni sorta. È indispensabile infatti far credere loro (e ai loro genitori) di stare imparando.
L’animazione presuppone che chi ha da imparare non desideri imparare e che per questo debba essere imbonito, trovando tutti i trucchi per convincerlo a fare una cosa che si pretende non voglia fare. L’animazione è una pratica che appartiene a una scuola che non riconosce agli allievi il desiderio di imparare: essa alletta il discente a trasformarsi in un “renitente all’apprendimento”. In altre parole, in un bisognoso da accudire. Ecco allora che l’animazione viene anche a rispondere al bisogno proprio di chi ne è dispensatore di sentirsi buono. Chi è dedito all’animazione può immaginarsi circonfuso di un’aura di bontà, compreso com’è ad accordare il proprio sostegno a irrimediabili, eterni bisognosi.
4. E tuttavia l’animazione può non bastare. Chi è soggetto ad esclusione può esternare il proprio patimento in forme inappropriate: possono fare cioè la loro comparsa “comportamenti a rischio”. Ed ecco allora il ricorso al monitoraggio continuo dei comportamenti di tutti per sorprendere sul nascere ogni indizio di devianza, l’allestimento di dispositivi di sorveglianza diffusa volti a poter individuare per tempo, tenere sotto controllo, ed eventualmente smistare e far scomparire in altri percorsi scolastici e “educativi” i “casi difficili”, gli irriducibili “iperattivi”, gli sconsiderati “guastatori”, i renitenti alla regola. All’animazione si affianca un proliferare dell’insistenza sullo stare e far stare alle regole. Il “saper essere” così smodatamente richiesto-imposto (quasi per decreto, o attraverso la finzione di “contratti educativi”) si risolve in un saper essere così come la nuova maniera di produrre desidera: saper essere soli, ma allo stesso tempo capaci di comunicare e di “lavorare in team”, flessibili, responsabili, disponibili a lavorare intensamente nei discontinui intervalli di tempo per i quali si è chiamati a “erogare le proprie prestazioni”, “risorse umane” capaci di conformarsi docilmente all’imperscrutabilità del ciclo economico. Un saper essere che implica la costruzione di comportamenti e procedure di comportamento artificiali, parole prestate a un comportamento che di suo non si manifesta. Procedure e codici di comportamento devono pertanto essere prescritti come regole-ricette da osservare, come viatico da fornire a chi, vittima di un estremo impeto di svalorizzazione, viene equiparato ad un automa al quale fornire gli imput necessari al suo funzionamento.
Per i trasgressori più ostinati e recidivi non resterà che la “tolleranza zero”.
5. Non essere sicuri di essere guardati pur nella certezza di poter essere controllati continuamente: la sottile inquietudine derivante dal poter essere oggetto dell’oscuro scrutare del sorvegliante induce il sorvegliato a mantenere costantemente il suo comportamento entro la norma. Pur non guardati a vista ci si adegua a soggiacere all’esercizio del potere. Siamo al cospetto della diffusa disseminazione dell’armamentario del Panopticon progettato da Bentham alla fine del 1700 “per castigare gli incorreggibili, controllare i pazzi, correggere i viziosi, isolare i sospetti e far lavorare gli oziosi”, perfetta struttura di reclusione che poteva servire ugualmente bene per manicomi, fabbriche, caserme o scuole. Siamo di fronte all’estremo tentativo di riuscire a presentarsi come funzionante ( sia pure al privato vantaggio di pochi) messo in atto dalla scuola del controllo, che non può certo pervenire ad arrestare il degrado del gusto di imparare e i cui danni, nella forma di una crescente disaffezione per il sapere e per il conoscere, sono sotto gli occhi di tutti.
6. Non per caso il disagio che investe la scuola ha come ultima manifestazione il riacutizzarsi del problema della lingua. Nelle scuole c’è una generale ritrosia e fatica ad esprimersi, si parla e ci si espone sempre meno, si scrive a stento, sono in aumento esponenziale i disturbi del linguaggio: ricompare, in altre parole, lo spettro dell’afasia. Le nuove generazioni si danno a vedere come individualità chiuse all’esterno, mute, incapaci di ascoltare e comunicare. Danno l’impressione di sottrarsi all’impiego della lingua in uso, una lingua non più riconosciuta come suscettibile di essere impiegata per dare significato alle loro vite, una lingua morta alla loro intima necessità di esprimersi, di esserci e di contare in questo mondo.
E significativamente il sottrarsi alla lingua data fa la sua comparsa nel momento in cui le trasformazioni intervenute nel processo produttivo comportano l’impiego, come “materia prima”, del sapere, dell’informazione, della comunicazione, nel momento in cui per le nuove forme della produzione chi lavora deve “saper essere” loquace.
7. Una scuola del controllo non può che ribadire la centralità del principio di prestazione, in ossequio al quale l’insegnamento si riduce alla trasmissione di un sapere che, immiserito per il suo rendersi estraneo alle soggettività in presenza, viene suddiviso in porzioni da somministrare sotto forma di obiettivi. Obiettivi per il cui raggiungimento occorrerà individuare sequenze di prestazioni allestite in modo da essere convenientemente misurabili e pertanto valutabili “oggettivamente”.
Ai genitori, ridotti in tal modo a spettatori consenzienti, il residuo compito di prendere (sempre più notarilmente) atto dell’esito delle verifiche attraverso le quali sono state testate le prestazioni dei figli, e se necessario, correre ai ripari (provvedendo di tasca privatissimamente propria) ricorrendo a un sovrappiù di scuola costituito da lezioni private e corsi estivi, un sovrappiù di scuola che latentemente affianca quella ufficiale per consentirne una parvenza di funzionamento. In realtà ingenerando negli “utenti” ulteriore noia e disaffezione. Un ruolo al quale i genitori difficilmente pervengono a sottrarsi, sospinti dal miraggio che i propri figli possano accedere a quell’esiguo 20% di eletti destinati a future posizioni di rilievo sociale ed economico.
8. Parallelamente alla riaffermazione del principio di prestazione, assistiamo nella scuola del controllo a un’attribuzione di enfasi a un malinteso principio di responsabilità: così come nella società ciascuno è individualmente ritenuto responsabile delle proprie opportunità economiche (solo chi non ha volontà non trova lavoro), o della propria salute (al punto che c’è chi sta ormai pensando che chi, consapevole dei rischi che corre, mette comunque coscientemente a repentaglio la propria salute non meriti di fruire dei contributi assicurativi ma debba privatamente farsi carico dei costi della propria salute), allo stesso modo nella scuola ciascuno è ritenuto responsabile del proprio apprendimento. Ciò comporta l’obbligo per l’allievo di essere capace di mobilitare tutte le proprie risorse per arrivare da sè all’acquisizione formale dei contenuti previsti e predisposti dalle sequenze della programmazione didattica. Per favorire quella creatività così richiesta dal mercato, basterebbero, nei processi di apprendimento, pochi “input” di stimolazione (da somministrare possibilmente sotto forma di gioco) per attivare l’autonomia e l’elasticità mentali attinenti ai processi cognitivi.
Che è come dire che l’attitudine all’acquisizione del sapere appare come un prerequisito, un già dato, sulla base del quale procedere a inclusioni, esclusioni, selezioni: chi c’è, c’è; chi non c’è, non c’è.
Siamo in presenza di una scuola che ha rinunciato a far crescere, e che pretende l’erogazione di comportamenti, saperi, procedure, disposizioni mentali di cui gli allievi dovrebbero già essere preventivamente dotati.
Una scuola che insegna a chi è già bravo a imparare e che rinuncia a misurarsi con la questione di un possibile ampliamento della disponibilità ad apprendere, una scuola che basa ormai la selezione sul come si è (già) è una scuola che vien meno ai suoi compiti, è una scuola che invece di ridurre il disagio contribuisce a produrlo.
9. Il venir meno di un reciproco richiamarsi delle soggettività di studenti e insegnanti confina l’insegnamento in un’ossequiante, asettica esecuzione di pianificazioni che tutto prevedono, dagli obiettivi agli itinerari per raggiungerli, organizzati secondo tempi prestabiliti e standardizzati, che comportano come norma richiesta lo “spontaneo”, automatico conformarsi all’erogazione di risorse, attitudini, comportamenti finalizzati al quieto assorbimento degli standard di contenuti e “competenze” comandati, e dati per scontati e acquisiti.
Prerequisiti, appunto, il cui allestimento è implicitamente ritenuto essere competenza e responsabilità delle famiglie.
Disseminare la scuola dei diffusi dispositivi di controllo e sorveglianza degli apprendimenti e dei comportamenti che un insegnare concepito come addestramento implica, significa consegnarla ad un accelerato deperimento.
L’insegnante della scuola del controllo, invece di poter fruire del tempo opportuno per far crescere, vede il proprio mestiere ridursi alle angustie di una tecnica di somministrazione di saperi preconfezionati (pur nella finzione che i discenti debbano farsi liberi costruttori del proprio sapere) e di una vuota enunciazione di norme di comportamento. È questa una tendenza ormai sedimentata, che sovraccarica di tensioni i rapporti tra dirigenti, insegnanti, genitori e, soprattutto, i rapporti tra adulti e ragazzi. Una tendenza che, appunto, produce disagio e vanifica l’apprendimento.
10. L’insistita sollecitazione a che gli alunni diano, si diano, eroghino forzosamente attitudini, prestazioni, comportamenti confacenti alle regole, l’intrusiva pretesa di poter disporre di interiorità trasparenti, non comporta, in contropartita, scambio alcuno: l’insegnante non dà più, non si spende (relazionalmente) più, non insegna più preferendo lasciare (in ossequio a un presunto antiautoritarismo) che siano gli alunni stessi a farsi promotori responsabili del proprio autoapprendimento. Senza ottenere nulla in scambio, e per di più esposta a costante sorveglianza, anche la più encomiabile attitudine a dare, progressivamente si spegne per cedere il campo a un muto ritrarsi. Un tale mancato incontro, una tale dismisura relazionale contribuisce a far sedimentare una modalità di crescita autoreferenziale in cui si finisce per convincersi che l’altro (l’adulto) è insignificante per l’apprendimento, che dall’altro non ci si deve aspettare di ricevere niente, e che, in prospettiva, ogni apporto dell’altro è irrilevante nella vita di individui sempre più indotti a concepirsi come singolarità isolate.
L’antiautoritarismo di facciata (buono per credersi e farsi credere buoni), l’assenza di una relazione che non dissimuli la disparità, celano il ricorso all’asettico dispotismo di norme, procedure e tempi di apprendimento che, facendosi scudo vuoi di una pretesa differenziazione dell’apprendimento, vuoi della libera facoltà di scelta, per gli allievi, dei curricoli che meglio loro si addicono, si incarica di provvedere silenziosamente ad escludere dall’accesso all’élite globalizzata chiunque non disponga delle adeguate credenziali per esservi ammesso. Una selezione massacrante, che priva i più della possibilità di accedere a un sapere che abbia un nesso con le loro vite, e che si presenta sotto le mentite spoglie di un’autoesclusione, imputabile unicamente a deficit individuali, a personali irresponsabilità, opportunamente e “oggettivamente” rilevabili e rilevate da un monitoraggio perpetuo.
11. Con l’affermarsi e il diffondersi della grande industria gli operai hanno progressivamente perso gli antichi saperi di mestiere di cui erano ancora portatori, saperi che sono stati centralizzati, monopolizzati dalle strutture direttive dell’organizzazione di fabbrica e inglobati negli automatismi produttivi per poi ergersi, come nuovo sapere tecnico privato, di contro a un nuovo tipo di operaio svuotato delle antiche conoscenze, ormai irrimediabilmente dimenticate. Ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso gli operai di una grande industria automobilistica sapevano “cucire un motore”, sapevano cioè rimediare ai difetti con cui il pezzo poteva uscire dalla fonderia, recuperandolo alla produzione. Operazione inimmaginabile solo pochi anni più tardi.
Similmente assistiamo oggi all’espropriazione di saperi radicati nella viva esperienza relazionale delle persone e alla loro sostituzione con saperi tecnicizzati, “indipendenti e separati dal vivere comune”. Il sapere che ha legami con la vita viene come tagliato via dalla vita; il comune sentire, il comune sapere (per lo più relazionale) viene inglobato in discorsi che si autoconferiscono un marchio di scientificità (ad esempio le “scienze umane”) e finisce, ricodificato e artificializzato, per ergersi contro i suoi originari portatori. Agenzie istituzionali, una volta divenute depositarie di un sapere devitalizzato in quanto ha subito un processo di oggettivizzazione volto a procurargli patente di scientificità depurandolo dagli indesiderati influssi della soggettività cui era originariamente indissolubilmente legato, pretendono al ruolo di dispensatrici di tecniche (per lo più procedurali) alle quali gli alienati utenti devono riaddestrarsi e uniformarsi, pena l’esser catalogati come devianti. Con il venir meno delle capacità relazionali si diffondono, non solo nella scuola, prontuari corredati dagli indispensabili applicativi, che prevedono protocollarmente, ad esempio, il saluto al “cliente” (per stabilire, va naturalmente specificato, un primo approccio di relazione), la presentazione, l’invito a creare una situazione accogliente per l’utente, l’opportunità di porsi in “posizione d’ascolto” verso eventuali richieste di informazione, e via elencando.
Il venir meno di “saperi radicati nell’esperienza viva dei singoli”, in campo educativo non può che dar luogo “ad una scuola che non sa insegnare”. In simili circostanze non c’è da stupirsi che l’approfondimento dell’apprendimento della lingua materna venga progressivamente ad assimilarsi all’apprendimento di una lingua straniera, vieppiù estranea ai suoi stessi locutori.
Un’indiretta, collusiva autorizzazione a procedere proviene agli apparati istituzionalmente investiti della gestione monopolistica dei rapporti umani dalla scelta di molti insegnanti di esentarsi da pratiche relazionali per immergersi in un’amplificata, ridondante disciplinarità. Là dove si pretende che le famiglie falliscano, non riuscendo a consegnare allievi già predisposti e conformi all’assorbimento di conoscenze, pongano rimedio dentro la scuola coloro che sono preposti a “gestire gli allievi”: per gli insegnanti potrà così tornare ad essere salvaguardata l’opportunità di procedere finalmente indisturbati alla trasmissione dei contenuti disciplinari delle rispettive materie.
Ad una riduzione delle pratiche relazionali a sequenze di prescrizioni fa eco una riproposizione della centralità dei saperi disciplinari: entrambi i processi sono accomunati dal bisogno di mettersi al riparo dagli effetti (indesiderati) dell’imprevedibile dispiegarsi delle soggettività in presenza.
12. Per l’insegnante accettare di essere soggetto alle formule di una burocratica ingegneria didattica significa accettare di disporsi alla propria attività sprovvisto di autorità. Un apprendimento che viceversa comporti una personale ricerca di senso non può accadere in presenza di procedure di controllo, nè in presenza di forme di autoritarismo (che, in quanto espressione di puro rapporto di forza costituiscono una corruzione dell’autorità), nè in presenza di una finzione di rapporto tra pari tra insegnanti e studenti, nè in presenza di indifferenza per le soggettività in campo. Esso può solo accadere dentro una relazione in cui sia operante una disparità in grado di orientare e dare misura, in cui chi insegna rinunci ad esercitare potere ma non si sottragga ad esercitare autorità.
Al contrario del potere l’autorità, per essere tale e dare frutti, non può che essere accettata e riconosciuta.
Dover sottostare a limiti promanati da figure di potere in forma di regole ossessivamente ripetute e/o implicitamente vigenti (e della cui inosservanza si può essere chiamati a rendere conto d’ufficio da istanze preposte a valutare e sanzionare ogni divergenza dalla norma), allontanando chi è tenuto a stare al limite da chi lo indica, preclude a chi sta imparando l’accesso a una relazione in grado di favorire itinerari di crescita e di ricerca libera e personale.
Là dove è presente autorità prevale invece la consensualità: in essa soltanto può dispiegare i suoi effetti una forma di disparità priva di dominio.
Di qui la fragilità di una pratica relazionale continuamente esposta al rischio di degenerazione. Ma di qui anche la sua fecondità e la sua portata, se solo si pone mente al fatto che il bambino impara a parlare all’interno di una relazione dispari, solo contesto che può far sedimentare in una pratica acquisita e rendere “operativo” il desiderio di parlare con la madre. Evento che ci segnala ulteriormente come l’autorità non può essere imposta-edificata con regole, ma ha piuttosto a che vedere con un riconoscimento fondato sulla fiducia.
Una libera capacità di simbolizzazione, esatto opposto della ripetizione coatta di codici stereotipati in cui il senso delle parole si consuma e decade, può accadere solo in un contesto relazionale in cui ci sia la disposizione a ricevere misura da qualcuno “più grande”, e in cui chi è “più grande” non si dimetta dal suo ruolo.
Il totalitarismo disfa autorità per sostituirla con potere. Ma un deficit di autorità compromette la capacità simbolica. Eichmann parlava un gergo menzognero e prefabbricato, infarcito di ripetizioni e di frasi fatte; era affetto da afasia ed era incapace di pensieri propri.
13. Per quanto attiene l’ambito educativo, standardizzazioni e pianificazioni non fanno che generare una istupidente monotonia favorendo la creazione di un ambiente negato agli incontri casuali, privo di qualsiasi fattore suscettibile di originare interessi, perplessità, passioni. Le nostre scuole sembrano strutturate apposta “per ospitare omuncoli, (…) creature raffazzonate da funzioni amministrative e definizioni giuridiche”. Ogni sforzo per omogeneizzare la vita scolastica, per renderla logica, funzionale, leggibile, si traduce, per chi è tenuto a farvi i conti, in una disintegrazione dei legami umani, in una penosa esperienza di solitudine, cui si somma una sorta di “analfabetismo morale” destinato ad affliggere chi si trovi nella necessità di affrontare autonomamente delle scelte. L’obiettivo della trasparenza comporta un prezzo terribile: la monotonia derivante da apprendimenti artificiali priva chi impara e chi insegna dell’opportunità di dare un senso alle cose. Non si diventa buoni “solo seguendo i buoni ordini o i buoni programmi di altri”.
Uno dei segreti di una “buona scuola” sta viceversa nell’offrire ai propri studenti la possibilità di assumersi la responsabilità dei propri atti in vista di doversi misurare con una società storicamente imprevedibile. Una scuola esente da sorprese, ambivalenze e conflitti è una scuola che non favorisce la crescita. Possono affrontare le proprie responsabilità solo coloro che hanno potuto misurarsi con l’incertezza; possono diventare persone mature “quegli esseri umani che crescono avendo bisogno dell’ignoto”.
Il presente artivolo è stato pubblicato in Verifiche, Periodico di cultura e politica dell’educazione, dicembre 2004, Mendrisio