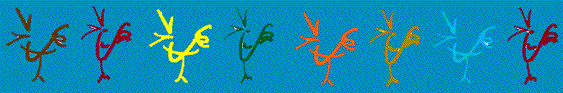Giovanni Galli, novembre 2025
Se parliamo dell’“ordine del discorso” in senso foucaultiano, cerchiamo di capire quali pratiche, norme, istituzioni e discorsi rendono possibile parlare di plusdotazione, quali sono i limiti e le regole implicite che stabiliscono cosa si può dire, chi può parlarne e con quale autorità.
Non parliamo tanto di definizioni psicologiche o pedagogiche, ma di come il sapere sulla plusdotazione si struttura socialmente e storicamente, secondo gli “attori e scenari” in gioco.
Con “L’ordine del discorso” mi riferisco principalmente ai meccanismi e alle regole di creazione, di espressione, di esclusione, controllo, limitazione e legittimazione che agiscono sui discorsi in una data società o epoca, determinando:
- chi può parlare (e con quale autorità),
- cosa può essere detto (e cosa è interdetto),
- dove e come il discorso può circolare,
riguardo l’alto potenziale cognitivo (plusdotazione)
Gli attori: sono i soggetti parlanti (gli individui o i gruppi) che partecipano al discorso legittimo (ad esempio, il medico, il professore, il politico). Le regole dell’ordine del discorso selezionano gli attori abilitati a produrre determinate verità.
Gli scenari: sono contesti istituzionali (o meno) e spaziali in cui il discorso viene prodotto, controllato e distribuito (ad esempio, la scuola, i media). Queste istituzioni definiscono uno scenario per altrettanti definibili tipo di discorso (tanto che se leggiamo un discorso possiamo individuarne il suo attore).
Nell’ordine del discorso sulla plusdotazione, oltre i professionisti dell’educazione e dell’età evolutiva, le scuole ed i suoi attori, i media, i giornalisti, lo Stato e i politici giocano un ruolo vitale, contribuendo a definire cosa è “importante”, “normale” o “problematico”.
Per la plusdotazione, possiamo articolare l’ordine del discorso così:
Chi può parlare:
- Psicologi, pedagogisti, neuroscienziati → hanno l’autorità accademica e clinica.
- Genitori e insegnanti → spesso parlano come testimoni o interpreti, ma la loro parola ha meno “autorità scientifica” nel discorso istituzionalizzato.
- Gli stessi plusdotati → storicamente raramente considerati come “esperti” fino a tempi recenti.
- Media (film, programmi TV, articoli giornalistici) → spesso creano stereotipi (il “bambino prodigio”, il “plusdotato problematico”).
- Social media → amplificano le voci dei genitori, ma possono diffondere informazioni fuorvianti.
- Politici e Stato (legislazione scolastica, finanziamenti per programmi di eccellenza, politiche pubbliche sulla plusdotazione) → definiscono chi ha diritto a supporto educativo.
Il discorso sulla plusdotazione è un campo di visibilità e legittimazione.
L’ordine del discorso sulla plusdotazione si struttura come una rete di attori con diversi livelli di autorità, interessi specifici e forme implicite di diniego.
La plusdotazione non è un fenomeno neutro o immediatamente percepibile: ciò che possiamo riconoscere, discutere o valorizzare dipende dalle reti di autorità, interessi e dinieghi che regolano chi può parlare, chi viene ascoltato e cosa viene considerato “vero”.
Al vertice di questa rete si collocano Stato e politici, che detengono l’autorità normativa più alta. Il loro interesse principale è organizzare le risorse pubbliche, stabilire le priorità educative e garantire equità e sostenibilità dei sistemi scolastici. In questo contesto, la plusdotazione viene riconosciuta solo se rientra in programmi considerati strategici, come i percorsi di eccellenza o le politiche di inclusione per talenti eccezionali. Il diniego dello Stato si manifesta quando certi bisogni educativi o forme di talento non convenzionali non ricevono attenzione: ad esempio, programmi scolastici standardizzati possono ignorare studenti che apprendono più velocemente o con modalità non lineari, rendendo invisibili alcune dimensioni della plusdotazione.
Parallelamente, media e giornalisti giocano un ruolo cruciale nella costruzione della visibilità pubblica della plusdotazione. Il loro interesse è raccontare storie che catturino l’attenzione: articoli sul “bambino prodigio”, servizi televisivi sul ragazzo che ha superato un test di QI straordinario, oppure inchieste su difficoltà comportamentali dei plusdotati. In questi casi, la narrazione diventa immediatamente accessibile al grande pubblico, ma spesso semplificata o stereotipata. Il loro diniego consiste nell’escludere la complessità psicologica, pedagogica o socio-emotiva: ad esempio, l’ipersensibilità emotiva o la fatica sociale del plusdotato raramente trova spazio, così come l’esperienza soggettiva dei ragazzi stessi.
Le istituzioni scolastiche rappresentano nodi centrali nella mediazione tra norme statali e pratica educativa quotidiana. Hanno autorità nell’organizzare classi, selezionare programmi, valutare risultati e implementare interventi pedagogici. Il loro interesse è garantire ordine, efficienza e coerenza curricolare; il diniego si manifesta quando la scuola non è in grado di adattare percorsi individuali o di riconoscere forme di eccellenza che non si conformano agli standard. Ad esempio, uno studente che apprende rapidamente ma mostra disinteresse per compiti ripetitivi può essere percepito come “difficile” o “disorganizzato”, e il suo potenziale rischia di rimanere invisibile.
All’interno delle scuole, insegnanti, psicologi e pedagogisti operano con ruoli complementari, ma differenti livelli di autorità e attenzione. Gli insegnanti, con autorità pratica sulla gestione della classe, hanno interesse a garantire che tutti gli studenti raggiungano gli obiettivi curricolari; il loro diniego può consistere nel trascurare bisogni individuali dei plusdotati o nel favorire strategie standard di apprendimento a scapito di percorsi più flessibili. I psicologi, con autorità scientifica e clinica, hanno interesse a osservare, diagnosticare e supportare lo sviluppo cognitivo ed emotivo; tuttavia, il loro diniego riguarda fenomeni non misurabili o non conformi a protocolli standardizzati, come forme particolari di creatività o motivazioni intrinseche. I pedagogisti, orientati alla progettazione educativa, cercano di modellare interventi adatti alle specificità degli studenti, ma possono ignorare approcci non convenzionali se non rientrano nei curricula ufficiali. Infine, i neuroscienziati, pur distanti dall’esperienza scolastica quotidiana, contribuiscono a consolidare un sapere scientifico che legittima certe osservazioni e ne esclude altre: l’interesse è spiegare biologicamente la plusdotazione, mentre il diniego riguarda dimensioni emotive, relazionali o culturali difficili da quantificare.
Ai margini della rete si trovano i plusdotati stessi e i genitori. I plusdotati hanno esperienza diretta e soggettiva della propria mente, delle proprie emozioni e dei propri stili di apprendimento, ma storicamente la loro autorità è bassa: raramente le loro percezioni vengono considerate come contributi epistemici al discorso scientifico o pedagogico. Il loro interesse è farsi comprendere, esprimere bisogni e idee; il loro diniego è l’invisibilizzazione, l’incomprensione o la delegittimazione della propria voce. I genitori, mediatori tra esperienza diretta e contesto sociale, hanno autorità limitata, ma cercano di garantire riconoscimento e tutela per i figli. Il loro diniego consiste nella difficoltà di modificare strutture istituzionali, narrazioni mediatiche o convinzioni scientifiche consolidate, e talvolta possono entrare in conflitto con scuole e psicologi.
In questo complesso intreccio di attori, interessi e dinieghi, il discorso sulla plusdotazione si conferma un campo di visibilità e legittimazione, dove la realtà dei plusdotati è riconosciuta, interpretata e valorizzata solo attraverso le dinamiche di potere, autorità e mediazione che la circondano. Ogni attore contribuisce a modellare ciò che diventa “visibile” e ciò che rimane ignorato, rendendo la plusdotazione un fenomeno socialmente costruito tanto quanto psicologicamente osservabile.
| Attore | Ruolo nel discorso della plusdotazione | Controllo esercitato |
| Psicologi, pedagogisti e professionisti dell’istruzione | Attori primari di “legittimazione”. Producono il discorso scientifico/clinico, definendo chi è plusdotato. | Controllo del “Come” (Metodo): custodiscono il rito della misurazione (il test del QI), il linguaggio tecnico e le procedure di valutazione. |
| Genitori | Attori di “riconoscimento e pressione”. Producono il discorso dell’esperienza e della richiesta di intervento (patrocinio). | Controllo del “dove” (Accesso): esercitano pressione affinché la scuola e il discorso scientifico (il dove) riconoscano e modifichino le proprie pratiche (il come) per accogliere e accudire il figlio. |
| I plusdotati stessi | “Soggetti parlanti e soggetti oggettivati”. Possono produrre un discorso di resistenza, auto-narrazione o rivendicazione (spesso dopo la valutazione). | Controllo sul “Cosa” (Contenuto): il loro essere plusdotati è spesso il risultato di un discorso altrui, ma possono sfidare le categorie stabilite raccontando il loro come esperienziale. |
| I media (giornalisti, influencer) | Attori di “amplificazione” e “semplificazione”. Distribuiscono il discorso su larga scala, creando immaginari sociali (genio, incompreso, bambino prodigio). | Controllo del “Cosa” (Immaginario): rendono la plusdotazione un argomento rilevante, ma spesso la deformano in spettacolo, decidendo cosa (quali storie) merita di essere detto pubblicamente. |
| Politici e Stato (Legislazione, Finanziamenti, Politiche Pubbliche) | Attori di “distribuzione e istituzionalizzazione”. Producono il discorso normativo (leggi, linee guida) che decide come e dove i fondi e le risorse devono essere allocate. | Controllo del “Dove” e “Come”(risorse e leggi): decidono se e quali programmi speciali esistono e come devono funzionare all’interno del sistema scolastico nazionale o locale. |
Giovanni Galli, novembre 2025
tutti i diritti riservati