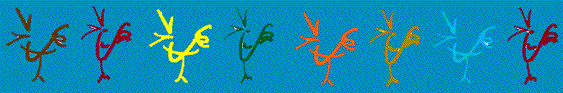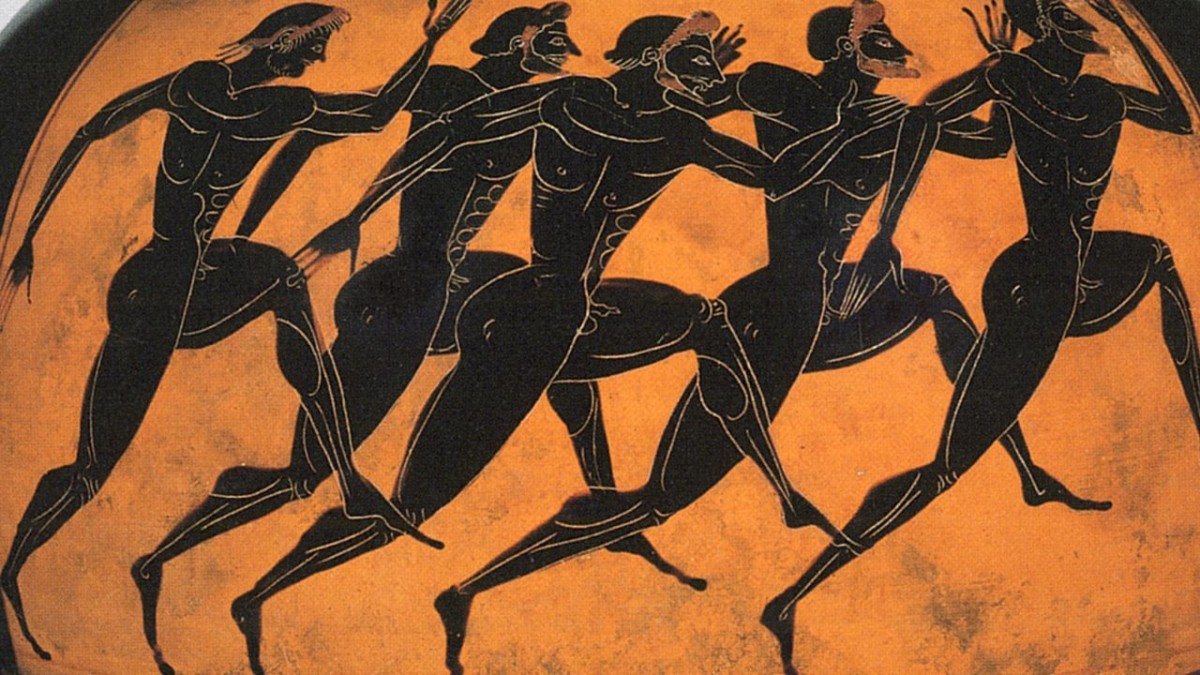Giovanni Galli
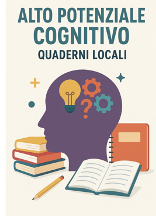
| Tratto da: APC: quaderni locali, numero 2, pagine 13-15, zetapiesse edizioni, Locarno, settembre 2025 Tutti i diritti riservati. |
1. Introduzione: il paradosso del ritmo
Parlare di “ritmo del pensiero” nell’Alto Potenziale Cognitivo (APC) significa scardinare l’equivoco della mera velocità. Non si tratta (solo) di un pensiero talvolta più veloce, ma di uno qualitativamente diverso: arborescente, capace di connessioni inattese, spesso intuitivo e a disagio con la linearità sequenziale. È un pensiero che procede per salti logici, che coglie la complessità in un istante e che soffre la frammentazione.
Qui emerge il paradosso APC che gli infligge l’apprendimento in contesto scolastico: l’alto potenziale, una capacità di processare a “100 km/h”, si scontra con l’atto di un apprendimento didattico che procede a “30 km/h”. Il “potenziale” (“alto”) entra in conflitto con un “atto” (“apprendere”) vincolato a strutture lente e ripetitive.
Questo articolo intende quindi analizzare l’inopportunità del sistema educativo standardizzato attraverso tre lenti concettuali: il Tempo, la Misura e la Differenza. Vedremo come il tentativo di imporre un tempo rigido e una misura universale fallisca nel comprendere l’APC, trasformando la sua differenza neurologica da potenziale a problema.
L’obiettivo è proporre un paradigma che smetta di tentare di normalizzare la differenza e inizi, finalmente, a valorizzarla come risorsa.
2. Il “Tempo” come gabbia: l’esperienza della disincronia esterna
Il concetto di “tempo” è forse la prima e più brutale gabbia in cui l’APC si scontra con il sistema. L’esperienza fondamentale è quella della disincronia: una discrepanza cronica tra un tempo interno, vissuto con intensità e accelerazione, e un tempo esterno, quello scolastico, che è lineare, frammentato, prevedibile e lento.
Cosa accade quando un allievo APC afferra un concetto nei primi due minuti di una lezione destinata a durarne cinquanta? Quel “tempo vuoto” che si genera non è neutro. Non è un tempo di riposo, ma uno spazio che si riempie di noia, frustrazione o ansia. È in questo vuoto che si radicano le strategie di sopravvivenza: l’iper-adattamento (mimetismo, il “falso sé” che finge di seguire per non disturbare) o, al contrario, l’evasione nel sogno ad occhi aperti o nel comportamento di disturbo.
Il sistema scolastico è costruito sul presupposto che l’apprendimento richieda una quantità fissa di tempo e ripetizione. Ma per l’APC, il tempo è una variabile, non una costante. L’apprendimento non è garantito dalla durata dell’esposizione, ma dall’intensità e dalla complessità dello stimolo. L’APC non ha bisogno di più tempo o di più ripetizioni, ma di più profondità. Imponendo un ritmo unico, la scuola non sta insegnando la pazienza, sta attivamente ostacolando un processo cognitivo che funziona secondo leggi diverse.
3. La “Misura” come illusione: oltre la “tirannia” del QI
Se il tempo è la gabbia, la Misura è l’illusione che rassicura il sistema. Voti, test standardizzati e, soprattutto, il Quoziente Intellettivo (QI) sono gli strumenti che la società utilizza per tentare di quantificare la “differenza” e renderla gestibile. Ma l’APC è, per sua natura, intrinsecamente “fuori misura”. Mi spiego.
La misura standard, infatti, si concentra sulla performance e sulla conformità a una media statistica, ignorando la complessità strutturale del potenziale. Il QI, qualora interpretato rigidamente come un punteggio monolitico, fallisce nel cogliere la qualità del pensiero. Come ben sottolineato il valore assoluto (il QI) nasconde le discrepanze tra le diverse scale (ad esempio, tra le abilità verbali e quelle visuospaziali o tra l’Indice di Abilità Generale e l’Indice di Competenza Cognitiva).
Quando l’analisi si ferma al numero (es. QI ≥ 130), si perde di vista il quadro complesso, il profilo: la disincronia emotiva, le fragilità relazionali e l’esperienza interiore. La misura si trasforma così in una mera etichetta — a volte positiva, a volte negativa (il “non si applica” di un alunno che ottiene un voro mediocre pur avendo un QI alto) — che, in entrambi i casi, nasconde la vera dinamica del potenziale. Tentare di imprigionare la fluidità e l’arborescenza dell’APC in una sola misura lineare non fa che generare frustrazione e rendere il potenziale stesso inaccessibile. La misura, insomma, diventa il tentativo di normalizzare la differenza, e in ciò fallisce, mascherando anziché rivelando.
4. La “Differenza” come risorsa: da problema a … potenziale
La Differenza è il punto di arrivo e, al contempo, il punto di svolta. Essa non è una caratteristica a sé stante, ma l’inevitabile risultato della frizione creata dalla discrepanza tra il “tempo” interno e la “misura” esterna. Fintanto che il contesto non è in grado di leggere e accogliere questa peculiare struttura cognitiva, la differenza si manifesterà come frattura.
È cruciale spostare la narrazione: l’APC non rappresenta una differenza quantitativa (un’intelligenza “più grande”), ma qualitativa: un modo diverso e arborescente di connettere, sentire e processare le informazioni. Di fronte a questa alterità strutturale, il sistema scolastico, non potendo gestirla con i suoi strumenti lineari, la trasforma nel sintomo: “non si applica”, “è distratto”, “è oppositivo”. Il problema non è il potenziale, ma l’ambiente che non offre l’ossigeno necessario alla sua espressione.
La vera sfida pedagogica consiste nel compiere il salto da misurare la differenza a usarla come una risorsa. Ciò richiede un cambio di paradigma: focalizzarsi non sulla performance (il voto, la misura), ma sul processo (il pensiero, il ritmo). L’ambiente (scolastico o familiare) deve diventare un facilitatore che riconosce il bisogno di complessità, che incoraggia l’esplorazione autonoma e che non teme l’asimmetria. Solo quando la Differenza viene vista come il punto di partenza per l’arricchimento e l’approfondimento – anziché come un errore da correggere per tornare alla norma – il potenziale può finalmente esprimersi pienamente.
5. Conclusione: riscrivere il ritmo
L’analisi del rapporto tra Tempo, Misura e Differenza nell’Alto Potenziale Cognitivo ci conduce a un’unica ineludibile verità: il fallimento non è nell’individuo con APC, ma nella rigidità del sistema che tenta di standardizzarlo. Quando il tempo imposto è un giogo di lentezza e ripetizione, e la misura è un numero che nasconde la complessità, la differenza del pensiero arborescente non può che emergere come sintomo di insofferenza o, peggio, di auto-sabotaggio.
L’obiettivo della pratica clinica e pedagogica non può essere quello di “normalizzare” l’APC, né di trovare “misure” sempre più precise per categorizzarlo. Si tratta invece di riscrivere il ritmo. Questo non significa semplicemente “accelerare” l’allievo (attraverso un salto di classe, che è una soluzione ancora legata alla logica del tempo), ma creare un ambiente che permetta la flessibilità temporale e l’arricchimento qualitativo.