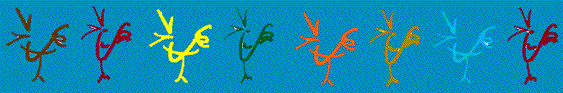Giovanni Galli, ottobre 2025
Alcuni processi di pensiero si sviluppano secondo una logica di accumulo e connessione. Tali modelli di conoscenza non si fondano sulla sequenzialità, ma sulla connessione.
Le idee, le domande, le informazioni, le conoscenze e, magari in forma più accademica, i dati vengono raccolti in forma di schede o frammenti, senza un ordine iniziale imposto.
In essi il sapere non procede per deduzione lineare, bensì per aggregazione reticolare: le informazioni, le ipotesi e le domande si dispongono come nodi in un campo, in cui ogni elemento può generare nuove costellazioni di significato.
Da questo insieme eterogeneo prende forma una mappa: una configurazione reticolare che consente attraversamenti diversi, non vincolati da una gerarchia. La mappa è un campo aperto, in cui le connessioni si moltiplicano e i percorsi restano potenzialmente infiniti.
La mappa rappresenta questa logica di fondo. È una struttura aperta e pluricentrica, priva di un ordine gerarchico stabile, che mantiene il sapere in uno stato di possibilità espansa. Ogni configurazione della mappa produce un possibile mondo di senso, distinto ma connesso agli altri: la conoscenza assume così una forma multiversale, dove più universi interpretativi coesistono e si intersecano.
Quando da questa struttura si tenta di ricavare un testo — un sentiero — si compie inevitabilmente un’operazione di selezione e di linearizzazione. Scrivere significa scegliere una direzione tra le molte possibili, dare forma sequenziale a un pensiero che, per sua natura, è simultaneo e ramificato.
L’impressione di insoddisfazione che può accompagnare questa fase deriva proprio da tale tensione: la mappa contiene più mondi di quanti il testo possa esprimere. Ogni percorso scelto ne esclude altri, che restano come possibilità latenti, come multiversi di senso.
Quando la conoscenza si traduce in un sentiero, avviene un passaggio epistemico: dalla dimensione potenziale e multidirezionale della mappa a quella selettiva e lineare del discorso. Ogni testo diventa allora la traccia di un universo fra i molti possibili, una proiezione parziale di un campo più ampio di relazioni.
La tensione fra mappa e sentiero riflette la dialettica fra complessità e formalizzazione: la prima tende a custodire la molteplicità, la seconda a ordinarla in un itinerario percorribile. In tale prospettiva, il pensiero non mira a ridurre la pluralità dei mondi a un’unica forma coerente, ma a riconoscere la coesistenza di più ordini di senso, ognuno dei quali illumina un diverso modo di comprendere.
Questa epistemologia del molteplice concepisce la conoscenza come campo generativo di mondi: ogni connessione apre possibilità nuove, ogni percorso tracciato lascia intravedere gli altri che potrebbero essere, in un movimento continuo fra mappa e sentiero, fra mondo e multiverso.
Mappa, sentiero e conoscenza nella plusdotazione
Nel pensiero e nell’apprendimento dei soggetti plusdotati si manifesta spesso una tensione fra due forme epistemiche: da un lato la forma lineare e narrativa del sapere, dall’altro la forma reticolare e generativa.
Questa tensione attraversa profondamente il loro modo di conoscere e di organizzare il mondo mentale, e si riflette tanto nelle loro prestazioni cognitive quanto nel vissuto emotivo che accompagna l’apprendimento.
Il sentiero: sicurezza e conformità
Lo studio a memoria, tipico di molti alunni plusdotati nella fase evolutiva, rappresenta un dispositivo di rassicurazione cognitiva. In apparenza può sembrare una modalità povera, riproduttiva, ma in realtà svolge una funzione regolativa: riduce l’ampiezza del campo conoscitivo e ne rende percorribile una sola via.
Il sapere mnemonico offre un sentiero tracciato, conforme alle aspettative scolastiche e sociali, in cui l’alunno può mostrare competenza senza esporsi al rischio dell’indeterminatezza. Si tratta, in altri termini, di una strategia di contenimento epistemico: aderire a un percorso predefinito consente di mantenere il controllo, di garantire coerenza e di ridurre l’ansia generata dall’eccesso di possibilità.
La mappa: molteplicità e disorientamento
La mappa rappresenta invece la forma del pensiero plurale e multidirezionale, quella che caratterizza più intimamente la plusdotazione. È una struttura cognitiva rizomatica, in cui le idee si ramificano e si connettono per affinità, analogia o intuizione più che per sequenza logica.
Questa forma di pensiero produce una molteplicità di mondi di senso, veri e propri multiversi epistemici, ciascuno dotato di una propria coerenza interna.
Per il soggetto plusdotato, però, la mappa può diventare fonte di entropia cognitiva: troppi legami, troppe direzioni possibili, una difficoltà costante a stabilire confini. Da qui può derivare una sensazione di disordine, di eccesso, o persino di minaccia: la mente, capace di vedere molte possibilità contemporaneamente, fatica a ridurle a un percorso coerente.
La tensione epistemica nella plusdotazione
L’alternanza fra mappa e sentiero è, nel soggetto plusdotato, una tensione strutturale. Da una parte, il bisogno di esplorare, di collegare, di pensare in termini di campi di possibilità; dall’altra, la necessità di chiudere la forma, di organizzare il pensiero secondo un asse narrativo o logico che ne renda possibile la comunicazione e la condivisione.
Lo studio a memoria emerge così come una risposta adattiva al conflitto interno fra complessità e ordine, fra apertura e struttura. Non rappresenta una regressione, ma una forma di autoprotezione epistemica, una modalità con cui la mente tenta di difendersi dal rischio del caos cognitivo.
Implicazioni educative e cliniche
Comprendere questa dinamica permette di ripensare l’intervento educativo e psicologico con la plusdotazione. Il compito non consiste nel forzare il passaggio dal sapere mnemonico a quello creativo, ma nel mediare tra mappa e sentiero, aiutando il soggetto a transitare tra le due forme senza perdere equilibrio.
L’obiettivo è consentire al pensiero di abitare la complessità senza esserne sopraffatto: riconoscere la legittimità del bisogno di struttura, ma anche nutrire la capacità di muoversi nei multiversi cognitivi in modo flessibile e consapevole.
In questa prospettiva, la plusdotazione appare come una forma epistemica amplificata, in cui la conoscenza non si limita a esplorare un mondo, ma tende a generarne molti. Il lavoro educativo e clinico diventa allora un accompagnamento nella traduzione: dal campo dei possibili al percorso condivisibile, dalla mappa dei multiversi al sentiero dell’espressione.
Giovanni Galli, tutti i diritti riservati,
ottobre 2025