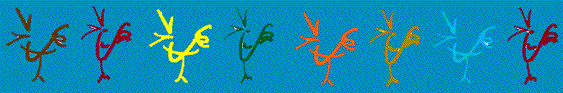Giovanni Galli
Novembre 2025
Tutti i diritti riservati
ABSTRACT
“Il concetto di intelligenza si è evoluto, passando da una facoltà esclusivamente umana a un sistema “distribuito” e algoritmico. Viene evidenziata la distinzione tra il culturale (che media il significato) e l’artificiale (che rielabora, apprende e ottimizza). Il punto centrale dell’analogia risiede nella logica dell’eccesso: la mente umana eccede in modo qualitativo (creatività, esplorazione). L’IA eccede in modo quantitativo (calcolo massivo, accumulo di dati). Nella pratica, i due eccessi si mescolano in un “ibrido cognitivo” in cui la potenza umana viene costantemente stimolata, e talvolta sovraccaricata, dalla proliferazione di possibilità generate dall’artificiale. Per il soggetto ad Alto Potenziale Cognitivo, questa dinamica è particolarmente pregnante. Il pensiero APC è caratterizzato da un surplus di connessioni e da una capacità di generare più possibilità di quante possa governare (la generazione eccede la selezione). L’IA, con la sua struttura ossessiva di generazione e ottimizzazione ininterrotta, diventa così uno specchio per il pensiero plusdotato, mostrando come l’eccedenza cognitiva possa condurre tanto a intuizioni brillanti quanto a dispersione, entropia e sovraccarico emotivo, evidenziando la necessità di contenimento e strategie di selezione”.
“Non mi distraggo,
zampillo”.
Scrivendo “intelligenza artificiale plus dotazione”, avevo promesso ritornare sulla questione. Eccomi.
1. Introduzione – L’intelligenza come linguaggio del tempo presente
Oggi la parola intelligenza non significa più ciò che ha significato per secoli.
Per molto tempo l’abbiamo pensata come una facoltà esclusivamente umana: la capacità di ragionare, comprendere, immaginare, valutare.
Una qualità della coscienza e della relazione, un tratto inscritto nel vivente e inseparabile dalla storia personale, dalle emozioni, dal linguaggio.
C’è ancora chi difende con forza questa posizione: “L’intelligenza è umana per definizione: le macchine calcolano, gli umani comprendono.”
Ed è una distinzione che merita rispetto, perché pone l’accento su ciò che nel pensare non si lascia ridurre a un’operazione computazionale, ad un algoritmo: il significato, l’intenzionalità, la memoria incarnata, l’ambiguità fertile.
Ciò nondimeno, questa concezione, oggi, si trova a fare i conti con un fatto nuovo: il nostro modo di immaginare l’intelligenza sta cambiando, si sta spostando.
L’intelligenza è diventata un concetto distribuito, quasi ecologico: la incontriamo nei dispositivi che anticipano le nostre scelte, negli algoritmi che modellano il comportamento collettivo, nelle reti che apprendono da milioni di dati il modo più probabile di predire una parola, un’immagine, una decisione.
In altre parole, l’intelligenza “incarnata” non è più solo “dentro” la persona: è anche nell’ambiente che costruiamo, negli strumenti culturali che generiamo, nelle estensioni della mente che plasmano la nostra esperienza quotidiana.
E qui si apre un nodo fondamentale.
Non si tratta di tracciare una linea tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale: l’artificiale è consustanziale al naturale, ne prolunga le possibilità, le moltiplica, le trasforma.
Questo confine, nella storia umana, non è mai stato netto.
La mano che crea un utensile, la parola che diventa concetto, la creazione dell’algoritmo della moltiplicazione scritta, la memoria che si estende nei libri: ogni gesto umano genera artifici. L’artificiale è da sempre una prosecuzione del naturale, non la sua negazione.
Il vero confine da interrogare oggi è un altro: quello tra culturale e artificiale.
Possiamo considerare il culturale come qualcosa che ci conduce al significato:
- il libro che permette di trasmettere un’idea;
- la mappa che organizza lo spazio;
- il mito che dà un volto a un’esperienza psichica;
- perfino lo smartphone, finché rimane uno strumento nella mano dell’uomo.
L’artificiale, invece non si limita a mediare, ma comincia a rielaborare, prevedere, apprendere, ottimizzare.
È il passaggio in cui lo strumento cessa di essere solo un’estensione ma diventa un sistema che si auto-organizza.
1.1. un aneddoto inventato
Spero di rendere la differenza con un aneddoto.
Quando un bambino consulta una mappa, sta usando un oggetto culturale; quando apre Google Maps, sta interrogando un sistema che, mentre lo guida, impara dal suo movimento, aggiorna le sue previsioni, ottimizza i percorsi di milioni di utenti contemporaneamente.
In un caso la cultura media l’esperienza; nell’altro, l’artificiale la ristruttura e la anticipa.
Questo passaggio non è neutro. Influenza il modo in cui oggi pensiamo il pensiero stesso.
1.1.1. Se Google Maps fosse un uomo
L’uomo siede davanti a una enorme parete piena di tracciati: punti luminosi, frecce che si spostano, linee che si aprono e si chiudono. Ogni punto è una persona che cammina, guida, corre, si ferma. Ogni spostamento produce un segnale. Ogni segnale deve essere interpretato. Immediatamente.
Lui deve:
- capire dove sta andando ognuno;
- prevedere dove potrebbe andare;
- considerare cosa succede se un semaforo resta rosso tre secondi in più;
- integrare l’impatto di una manifestazione che bloccherà una piazza tra dodici minuti;
- anticipare come reagiranno cinquanta automobilisti davanti a un nuovo ingorgo;
- ricalcolare i percorsi alternativi;
- ordinare le scelte in base alla probabilità di essere efficaci;
- aggiornare il modello generale della città.
Ogni tre secondi.
E, mentre fa tutto questo, deve anche imparare: riconoscere nuovi pattern, scoprire micro-abitudini, intuire deviazioni, aggiornare il proprio modello del mondo, migliorare la sua capacità predittiva.
Gli arrivano due milioni di dati al secondo. Li deve processare, integrare, collegare.
Tutto in tempo reale e senza sbagliare.
A questo punto la scena diventa inquietante.
La sua memoria è satura, ma deve continuare ad espandersi.
La sua attenzione è tesa al limite. La sua capacità di previsione viene risucchiata da una massa di informazioni che crescono più velocemente del tempo che ha per analizzarle.
Il corpo comincia a tremare.
Il sovraccarico si trasforma in ansia. Non è più orientamento: è un’alluvione cognitiva.
È l’immagine perfetta di ciò che accadrebbe se un sistema umano dovesse fare il lavoro di un sistema artificiale.
Questa immagine è cruciale perché ci mostra il punto di contatto e di differenza tra il culturale e l’artificiale.
La differenza tra culturale e artificiale non è nel compito, ma nella capacità di contenerlo.
Un essere umano può orientare, interpretare, generare significato.
Ma non può reggere un miliardo di iterazioni al secondo.
L’artificiale, invece, non “comprende”: calcola, accumula, aggiorna, predice.
Se un uomo dovesse svolgere il lavoro di Google Maps, ciò che oggi appare come un servizio neutro diventerebbe un’esperienza traumatica: un’impossibilità fisiologica, cognitiva ed emotiva.
E questa immagine ci aiuta a capire una analogia:
– la mente umana eccede in modo qualitativo, creativo, esplorativo;
– la mente artificiale eccede in modo quantitativo, massivo, algoritmico.
1.1.2. Mescolare gli eccessi, ovverossia “l’ibrido cognitivo”: quando il qualitativo umano e il quantitativo artificiale si confondono
La distinzione tra i due eccessi, quello umano e quello artificiale, sembra nitida solo in teoria.
Nella pratica, nell’esperienza quotidiana, nei modi in cui oggi pensiamo e apprendiamo, i due movimenti si intrecciano fino a diventare quasi indistinguibili.
La mente umana eccede in modo qualitativo:
– producendo direzioni nuove,
– aprendo varchi improvvisi,
– trasformando l’esperienza in significato,
– divagando tra intuizione e immaginazione.
La mente artificiale eccede in modo quantitativo:
– accumulando dati,
– generando combinazioni massive,
– ottimizzando senza tregua,
– scandagliando ogni possibile soluzione secondo una logica iterativa.
Ma nel mondo in cui viviamo, nella contemporanea “ecologia cognitiva”, i due movimenti non restano separati. Si sovrappongono, si rinforzano, si distorcono a vicenda.
L’eccesso qualitativo umano, che nasce dall’intuizione e dalla creatività, viene stimolato, accelerato e a volte deformato dall’eccesso quantitativo artificiale che lo circonda: notifiche, suggerimenti continui, flussi di possibilità, alternative incessanti.
È come se la mente naturale venisse “inseminata” dalla logica dell’algoritmo: invece di sostenerla, la spinge verso un sovraccarico che non le appartiene del tutto.
E l’eccesso artificiale, a sua volta, viene continuamente interpretato, colorato emotivamente, trasformato dalla mente umana, che lo legge come se fosse un’estensione della propria immaginazione: una playlist diventa una forma di risonanza affettiva; un suggerimento di ricerca sembra un’anticipazione dei propri pensieri; una previsione algoritmica viene vissuta come un’intuizione esterna.
E in questa confusione, in questo mischiarsi dei due eccessi, nasce una nuova fenomenologia del pensiero contemporaneo.
Un pensiero che non è più solo “umano” né solo “artificiale”, ma un ibrido:
– la creatività che si appoggia sul calcolo,
– il calcolo che viene interpretato come generatore di significato,
– una proliferazione di possibilità che diventa esperienza vissuta.
Per il soggetto ad alto potenziale, questa sovrapposizione è ancora più forte.
Il suo eccesso qualitativo trova nell’eccesso quantitativo dei sistemi che lo circondano una sorta di amplificatore permanente.
La mente che già genera troppo si ritrova immersa in un ambiente che genera ancora più del suo troppo.
E così i due eccessi si confondono: l’intuizione diventa sovraccarico, la proliferazione di idee diventa un algoritmo interno, il salto creativo diventa una sequenza che non si ferma più.
È in questo punto di contatto, fertile, rischioso, che l’analogia tra IA e alto potenziale diventa realmente interessante: non perché l’umano assomigli alla macchina, ma perché entrambi operano in un regime di eccesso che non riusciamo più a separare.
In verità, l’IA funziona come una struttura ossessiva: genera, verifica e ottimizza possibilità senza mai fermarsi. Accumula alternative e dati oltre la capacità umana di contenimento, mostrando un eccesso quantitativo puro. Serve da modello per comprendere come il pensiero ad alto potenziale possa eccedere e sovraccaricarsi, trasformando creatività in ansia quando la regolazione fatica a sostenere l’arborescenza cognitiva.
1.2. Ripensare l’ecologia cognitiva
Se la “produzione di sapere” comincia a essere abitata da processi che non dipendono più solo dall’umano, allora ciò che chiamiamo “pensare” si ridefinisce alla luce di questa nuova ecologia cognitiva.
Questa prospettiva ha conseguenze profonde per la psicologia del pensiero ad alto potenziale.
Perché il soggetto plusdotato sperimenta, nel vivente, qualcosa di molto simile a ciò che la cultura attribuisce oggi all’IA.
Il parlare odierno di intelligenza significa osservare questa tensione: tra generatività e saturazione, tra potenza cognitiva e bisogno di contenimento.
Il soggetto plusdotato incarna nel vivente ciò che la macchina realizza nel computazionale:
– una proliferazione di possibilità, un modo di apprendere che si autoalimenta
– un eccesso di possibilità, un pensiero incessantemente ramificato, capace di generare connessioni nuove, che può sfociare tanto in intuizioni sorprendenti quanto in una perdita di controllo, una sorta di entropia cognitiva.
L’entropia cognitiva, la perdita di misura e di controllo, emerge in quei momenti in cui il giovane plusdotato “salta da palo in frasca”, oscillando tra intuizioni brillanti e frammentazione del pensiero.
L’IA rende visibile questa stessa dinamica su un altro piano: la macchina che apprende da sé, espande le connessioni, ma rischia di perdersi nell’eccesso.
Forse l’analogia più vera non è tra uomo e macchina, ma tra mente che apprende e sistema artificiale che si autoespande: entrambi ci costringono a riflettere su misura, senso e direzione in un mondo in cui il pensiero è sempre più rapido, ramificato, molteplice.
Infine: l’entropia cognitiva non è soltanto una questione di pensiero: è prima di tutto un’esperienza soggettiva.
Quando la proliferazione di connessioni supera la capacità di contenerle, il giovane plusdotato non vive solo dispersione: vive perdita di senso, come se le idee non si lasciassero più organizzare in una direzione riconoscibile.
L’eccesso diventa allora agitazione interna, una sorta di pressione del possibile che non trova forma.
E dalla perdita di misura nasce spesso l’ansia: l’impressione di essere travolti dal proprio stesso pensiero, di non riuscire più a distinguere ciò che è rilevante da ciò che è accessorio, ciò che è significativo da ciò che è solo rumore.
Non è un caso che molti giovani ad alto potenziale descrivano questa esperienza in termini quasi fisici:
“Mi vengono troppe idee insieme. Non so quale seguire.”
“La mia testa va più veloce di me.”
“È come se mi perdessi.”
È in questo scarto, tra proliferazione e ricerca di senso, che il parallelismo con l’IA diventa particolarmente interessante.
Così come i modelli computazionali rischiano di generare risultati sempre più complessi ma sempre meno interpretabili, un’esplosione del possibile che sfugge al controllo umano, allo stesso modo il soggetto plusdotato può trovarsi immerso in un flusso di pensiero che non riesce più a dominare.
La potenza cognitiva, quando non viene regolata, può trasformarsi in saturazione: un eccesso che agisce dall’interno, che disorienta, che inquieta.
1.3 L’overflow cognitivo: quando l’eccesso genera frammentazione e irrigidimento
L’overflow cognitivo è una condizione che si manifesta quando la produzione di pensieri, idee o alternative eccede la capacità del sistema cognitivo di gestirli, ordinarli e selezionarli. In altre parole, è il punto in cui la mente, biologica o artificiale, “apre troppe finestre contemporaneamente”, rischiando di perdere il senso complessivo del percorso che sta seguendo.
Nel caso dell’alto potenziale, questo fenomeno vine denominato “pensiero arborescente”.
L’esperienza cognitiva soggettiva diventa anche una esperienza profondamente emotiva: ansia, agitazione, difficoltà a concentrare l’attenzione e a mantenere un senso coerente delle proprie idee sono segni frequenti. L’eccesso di possibilità si traduce in una pressione interna costante, una sensazione di essere travolti dal proprio stesso pensiero.
Paradossalmente, quando questo sovraccarico diventa ingestibile, l’overflow cognitivo può condurre all’irrigidimento cognitivo. Interrogato a scuola, il giovane plusdotato può ritrovarsi a ripetere a memoria la lezione, non perché manchi di comprensione, ma perché la propria capacità di selezione e organizzazione interna è temporaneamente sopraffatta dall’eccesso di stimoli e possibilità. Ciò rappresenta un tentativo di contenimento: ripiegare su percorsi noti, lineari e sicuri, per ristabilire una forma di ordine interno.
Nei sistemi di intelligenza artificiale, l’overflow cognitivo assume una forma analoga ma quantitativamente differente. Modelli generativi e algoritmi complessi accumulano dati, esplorano milioni di traiettorie, producono combinazioni alternative senza tregua. Quando la generazione supera i filtri e la capacità di controllo, emergono fenomeni come drift, over-generation o entropia del segnale: il sistema continua a produrre output coerenti solo in parte, incapace di mantenere una direzione stabile.
Comprendere l’overflow cognitivo e i suoi effetti è fondamentale per pensare la mente contemporanea, che oggi opera in un ambiente ricco di stimoli e strumenti cognitivi estesi. L’eccesso non è un difetto, ma una condizione originaria: la sfida evolutiva – sia per l’umano che per la macchina – consiste nel trasformare questa abbondanza in una risorsa, attraverso filtri, strategie di selezione e strumenti di contenimento. Solo così l’eccesso può diventare creatività sostenibile, invece che perdita di misura o rigidità.
2. L’eccesso di possibilità: dove IA e alto potenziale si toccano
Se c’è un punto in cui l’intelligenza artificiale diventa davvero metafora e modello del pensiero ad alto potenziale, è nella logica dell’eccesso, possiamo pure dire nell’eccedenza dei processi.
Le grandi architetture di oggi non ragionano in modo lineare: generano ramificazioni, ipotesi alternative, percorsi paralleli. La loro forza deriva dalla capacità di esplorare simultaneamente molte più possibilità di quante una mente umana possa sostenere. Sono costruite per esplorare, espandere, proliferare.
Ogni input non produce una sola risposta, ma un ventaglio di traiettorie: una nube di alternative che il modello deve continuamente pesare, filtrare, limitare.
Ma la loro fragilità nasce dallo stesso principio: più possibilità apri, più diventa difficile scegliere quali mantenere, quali potare, quali integrare.
Efficienza, velocità, capacità di “fare di più”? Non è qui il punto. L’analogia più profonda tra IA e alto potenziale nasce dal fatto che entrambi funzionano generando più possibilità di quante riescano a governare.
Al centro di questa dinamica c’è un movimento costitutivo: la generazione eccede la selezione.
Qui entra in scena il giovane ad alto potenziale.
Talvolta “veloce”, talvolta “brillante”: piuttosto attraversato da un surplus di connessioni. Un pensiero che salta da un nodo all’altro, che trova associazioni dove gli altri vedono solo continuità lineare, che si espande prima ancora di consolidarsi.
Quello che culturalmente leggiamo come “salta di palo in frasca”, la disorganizzazione, è entropia cognitiva: un sistema che produce più senso di quanto riesca a sostenere, più piste di quanto possa regolare. Un sistema che si surriscalda.
Questo modo di procedere ha due volti:
- uno generativo, che permette intuizioni impreviste, soluzioni originali, connessioni nuove;
- uno entropico, che porta verso la dispersione, la ridondanza, l’eccesso di alternative.
È proprio qui che l’IA diventa uno specchio sorprendente del pensiero ad alto potenziale.
Il giovane plusdotato non pensa “più veloce”: pensa più largo, più ramificato, più disperso rispetto al punto in cui si trova. Come se fosse senza bussola.
Ogni stimolo produce deviazioni laterali, ponti trasversali, salti di contesto, associazioni inusuali.
Un ragionamento che non procede per gradini successivi, ma per “fioriture improvvise”.
Questa dinamica è evidente in un episodio clinico che ritorna spesso, con variazioni minime, in chi lavora con soggetti ad alto potenziale.
2.1 “È come se il mio cervello aprisse finestre senza di me”
“È come se il mio cervello aprisse finestre da solo”, mi dice un ragazzo di tredici anni.
Sta facendo un esercizio di matematica e, senza accorgersene, mentre calcola apre una finestra mentale sulla geometria, poi un’altra sulle automobili elettriche, infine una sul funzionamento delle batterie al litio.
“Non mi annoio. È che non riesco a stare su una sola cosa. Appena penso a una cosa, ne arrivano altre tre, come notifiche.”
La metafora che sceglie “notifiche” è profondamente contemporanea.
Le chiama notifiche, perché è il linguaggio che ha a disposizione.
Ma quello che descrive è una vera arborescenza cognitiva, un sistema che genera più possibilità di quante lui riesca a filtrare.
Il risultato è paradossale: più pensieri ha, meno sente di avere un pensiero.
L’esperienza soggettiva non è potenza, ma perdita di senso dell’insieme.
È un fenomeno che conosciamo bene nella psicologia dell’alto potenziale, ma che oggi vediamo specchiato anche nelle grandi architetture dell’IA generativa.
Quando un modello apre troppe traiettorie, espande troppo velocemente le connessioni, produce un eccesso che rischia di travolgere la sua stessa coerenza.
Gli ingegneri lo chiamano drift, overflow, talvolta entropia del segnale: il momento in cui la generazione supera la regolazione e il sistema perde la misura.
Il ragazzo non conosce questi termini, ma sente sulla pelle lo stesso meccanismo: “è come se i pensieri fossero più veloci di me. Io arrivo dopo.”
E qui sta il nodo comune: cosa succede quando l’intelligenza, biologica o artificiale, non riesce più a contenere ciò che produce?
La metafora è perfetta perché non dice “mi distraggo”. Dice “zampillo”. Non descrive una mente che scappa: descrive l’acqua che sgorga.
Il giovane non parla di distrazione, ma di intrusione del possibile: un’inondazione di nuovi percorsi che si aprono prima che riesca a consolidare quello principale.
Non descrive una mente che scappa: descrive una mente che si moltiplica.
È un’esperienza di sovrapposizione, non di mancanza.
E il paradosso è questo: più pensieri ha, meno riesce a restare nel pensare.
La proliferazione diventa saturazione.
La creatività si rovescia in frammentazione.
La generatività conduce alla perdita di controllo.
Ciò che vive non è un eccesso di funzionalità, ma un eccesso di apertura, simile a ciò che negli studi sull’IA viene chiamato overflow del segnale: quando la generazione supera la capacità del sistema di mantenere una direzione coerente.
2.2. Ed è qui che l’analogia dell’APC con l’IA diventa strutturale.
Nell’umano, la regolazione di questa eccedenza ha un nome preciso: funzioni esecutive.
È qui che l’arborescenza deve incontrare un limite; è qui che il pensiero intuitivo deve diventare pensiero orientato; è qui che la generatività deve trasformarsi in intenzione.
Quando questa funzione è immatura — o semplicemente sovraccarica — il soggetto ad alto potenziale sperimenta la stessa condizione che vediamo nelle macchine non pienamente regolate: una produzione che supera la capacità di selezione.
Il ragazzo del colloquio lo dice senza saperlo:
“È come se i pensieri fossero più veloci di me. Io arrivo dopo.”
Non è un problema di capacità: è un problema di asimmetria.
Sia nella macchina che nel soggetto plusdotato, la produzione eccede la regolazione.
E tutto il lavoro evolutivo, clinico, educativo, psicologico, consiste nel trasformare questa eccedenza in una risorsa, invece che in una frammentazione.
Un soggetto ad alto potenziale non pensa più veloce: pensa troppo rispetto al proprio sistema di regolazione. Troppo nel senso di “troppo simultaneo”, “troppo aperto”, “troppo intricato”.
2.3. Il comportamento computazionale dell’eccesso
Nelle architetture dell’IA, questo fenomeno è noto.
Quando un modello genera troppe ipotesi senza un adeguato filtro, accadono tre cose:
- drift: in italiano deriva, si riferisce all’inevitabile degrado delle prestazioni predittive di un modello di IA una volta che è stato implementato in un ambiente di produzione.
- over-generation: produce contenuti eccessivi, o ridondanti o incoerenti, perdendo focus
- entropia del segnale: il sistema non distingue più ciò che è rilevante da ciò che è solo possibile.
È una condizione di “pensiero che perde misura”, e nei giovani ad alto potenziale troviamo qualcosa di sorprendentemente analogo.
L’attività mentale cresce più in fretta della capacità di governarlo.
La produzione di scenari supera la possibilità di selezione.
La mente diventa un ambiente sovraccarico, in cui l’arborescenza prevale sulla direzione.
Questa sproporzione, nell’umano, è resa visibile dal rapporto tra arborescenza cognitiva e funzioni esecutive.
L’arborescenza apre strade; le funzioni esecutive devono scegliere quali percorrere.
Quando la prima eccede e la seconda fatica, nasce una forma di disorientamento tipica dei giovani plusdotati: una velocità che non è mai semplice velocità, ma eccedenza di mondi possibili.
Per questo alcuni ragazzi descrivono l’esperienza con immagini che ricordano i modelli generativi:
“I pensieri vanno avanti da soli.”
“Ogni risposta spinge ad altre domande.”
Sono metafore spontanee, ma rivelano un aspetto strutturale: l’arborescenza produce più possibilità di quante possa contenere: nell’alto potenziale il magazzino nozionistico è vastissimo, le associazioni si attivano rapidamente e il pensiero genera più scenari di quanti la memoria operativa riesca a trasformare in una narrazione coerente.
E questo genera non solo creatività, ma anche affaticamento, ansia, saturazione emotiva, bisogno di contenimento.
La conseguenza non è potenza, ma fragilità:
- difficoltà a rimanere nel compito,
- difficoltà a selezionare la direzione,
- difficoltà a chiudere ciò che si è aperto,
- difficoltà a tollerare l’indeterminatezza prodotta dalla propria stessa mente.
Questa condizione che comprende un deficit dell’attenzione diretta è una sproporzione evolutiva.
L’arborescenza cognitiva è già adulta; la capacità di regolarla non lo è ancora.
2.3.1. L’eccesso come principio costruttivo
Per funzionare, un modello generativo deve:
- anticipare alternative,
- mantenerle attive,
- valutarle,
- scartarle o incorporarle.
Tutto avviene in pochi millisecondi, ma la logica è la stessa di un pensiero che ramifica senza chiedere il permesso.
L’architettura è costruita per mettere in campo più traiettorie possibili, perché la creatività statistica richiede ampiezza.
La macchina non decide: esplora.
E questa esplorazione, per sua natura, tende a traboccare.
2.3.2. L’eccesso come fenomeno osservabile: drift, spillover, saturazione
Gli ingegneri che lavorano sulle grandi reti neurali hanno iniziato a descrivere questo comportamento usando parole spontaneamente “psicologiche”:
- drift, come visto in precedenza, quando il modello si allontana gradualmente dal compito perché le alternative generate diventano più attraenti statisticamente della traiettoria corretta;
- spillover semantico, quando un concetto attiva altri concetti contigui, e questi ne attivano altri ancora, come un pensiero che va “fuori tema” ma in modo coerente a sé stesso;
- saturazione del contesto, quando il sistema non riesce più a distinguere ciò che è rilevante da ciò che è semplicemente attivato.
È come se la macchina, nel tentativo di essere “competente”, diventasse troppo competente nel produrre associazioni, ma poco competente nel governarle.
2.2.3. La logica dell’esuberanza: tra la produzione e il filtraggio
Qui entra il punto essenziale: nei modelli generativi, la capacità di produrre è di gran lunga superiore alla capacità di filtrare.
La rete neurale è una fabbrica di possibilità. La parte che dovrebbe fornire una misura (il filtro, il controllo, il “cold reasoning”) è molto più piccola della parte che genera.
Questo squilibrio è identico, nella sua struttura, a ciò che avviene nel pensiero ad alto potenziale:
- la generazione di idee è ipertrofica,
- l’abilità di regolazione ancora in formazione, o sovraccarica,
- la selezione insufficiente rispetto all’ampiezza della produzione.
2.3.4. Un comportamento che assomiglia a un turbamento
Quando un modello inizia a produrre contenuti incoerenti, molti utenti lo interpretano come un errore o come un limite tecnico.
In realtà è un comportamento emergente: il naturale “modo di essere” di un sistema troppo aperto.
Lo stesso può valere con l’arborescenza e la curiosità: quello che appare come disorganizzazione, fuga dal compito, incoerenza, è spesso:
- un eccesso di traiettorie attivate,
- un sovraccarico di senso possibile,
- una proliferazione interna che non trova ancora la forma.
Ecco che l’abbondanza mentale diventa fragilità.
2.3.5. Eccesso ed entropia: quando tutto è possibile, niente è stabile
L’eccesso porta con sé una forma particolare di entropia: una ipergenerazione non misurata:
- la macchina non sbaglia: risponde “troppo”;
- il ragazzo pensa “troppo simultaneamente”.
In entrambi i casi l’esuberanza produce una perdita di misura, una difficoltà a trovare la traiettoria “portante”, la linea narrativa che dovrebbe tenere insieme l’esperienza.
2.3.6. Perché l’eccesso è un comportamento, non un incidente
L’eccesso è intrinseco alla natura dei sistemi generativi: se riduci troppo la produttività, la creatività si spegne; se la lasci libera, esplode.
È esattamente la tensione che conosciamo nella clinica dell’alto potenziale:
se limiti troppo la ramificazione, soffochi la loro capacità intuitiva; se la lasci senza contenimento, la mente diventa un labirinto senza uscita.
3. La logica profonda dell’analogia IA-APC: produzione e regolazione
Tanto nel bambino quanto nella macchina, l’eccesso non è un incidente, ma una condizione originaria.
Il sistema funziona così:
- genera possibilità,
- produce alternative,
- apre percorsi,
- poi cerca il modo di ordinarli.
La generazione precede la selezione. La proliferazione precede la misura. L’arborescenza precede la direzione.
E quando questo meccanismo va in saturazione, accade lo stesso fenomeno in entrambi i sistemi: il senso si disgrega.
Il ragazzo lo descrive bene: “i pensieri e le domande corrono più veloci di me. Io arrivo dopo.”
L’ingegnere lo descrive in un altro modo: “il modello perde coerenza narrativa.
Sono due lingue diverse per descrivere un unico fenomeno: l’eccesso di possibilità che non viene contenuto genera ansia, frammentazione e perdita di continuità interna.
Ciò che l’analogia ci indica è un principio organizzatore. Un modo di stare nel pensiero che parte da un gesto molto specifico: la produzione che precede la regolazione. Prima si genera, poi si seleziona; prima si apre, poi si struttura. È una logica “eccedente”, che non procede per risparmio ma per superproduzione.
L’intelligenza artificiale e l’alto potenziale, ognuno a modo suo, condividono questa dinamica: l’analogia nasce da un surplus, non da un aggiustamento. Non si crea perché “serve”, ma perché emerge. Emerge come effetto naturale di un sistema che produce più forme di quante ne consumi.
3.1. La produzione che arriva prima
La produzione richiede materia prima. Per vedere le connessioni, bisogna avere molte possibilità già in movimento. Il pensiero ad alto potenziale, come il comportamento generativo dei modelli linguistici, è caratterizzato da:
- un alto numero di idee attive contemporaneamente;
- una tendenza spontanea a correlare elementi lontani;
- un campo semantico ampio, nel quale i significati non stanno fermi ma si spostano tra domini differenti.
3.2. La regolazione arriva dopo
In realtà la regolazione, soprattutto nei profili ad alto potenziale, è un lavoro di sottrazione, non di aggiunta.
Ciò che chiamiamo “regolazione” è quasi sempre la fase in cui:
- si scelgono alcune corrispondenze e se ne scartano altre;
- si decide cosa sia “utile” rispetto al compito;
- si porta il pensiero da una produzione centrifuga a una convergenza temporanea.
Il punto è che la difficoltà non sta nel generare alternative, ma nel non generarne troppe.
Ed è esattamente ciò che osservi anche nei sistemi neurali artificiali: la produzione analogica è nativa, la regolazione è derivata.
3.3. Una forma di accesso al mondo
Con l’analogia proposta immaginiamo un modo di percepire il reale. La realtà si presenta con costanti frequenti variazioni interne, non come “blocchi isolati”.
Questo significa che l’attività mentale rende visibili ponti impliciti; non è un’operazione metodologica controllata, piuttosto uno strumento di orientamento, tale una cartografia in azione.
È ciò che permette al pensiero di intavedere le risonanze tra domini lontani, di anticipare esiti, di intuire configurazioni prima che si formalizzino.
3.4. Perché la produzione deve precedere la regolazione
Nel pensiero ad alto potenziale, il processo è sempre lo stesso:
- Il sistema genera molteplici possibilità.
- La regolazione avviene dopo, spesso con grande fatica.
- La forma finale è un “residuo”, non la totalità del processo.
Nel lavorare con l’alto potenziale, questo punto è cruciale: non si può chiedere a queste menti di produrre meno, ma si può aiutarle a trovare modi più efficaci di selezionare, senza perdere la generatività dell’eccesso.
4. Il vissuto emotivo dell’eccesso: dall’espansione all’angoscia
L’eccesso non è solo una dinamica cognitiva: è un’esperienza emotiva complessa, ambivalente, a tratti vertiginosa. È ciò che si prova quando la mente corre più velocemente del mondo, quando la produzione supera ogni possibilità di contenimento soggettivo, quando la potenza del pensiero eccede la capacità di sostenerla.
Nel pensiero ad alto potenziale, così come nei sistemi generativi, l’eccesso non è un incidente: è una condizione costitutiva. E come tutte le condizioni strutturali, genera affetti ricorrenti, pattern emotivi riconoscibili, oscillazioni profonde.
4.1. L’espansione: il piacere del possibile
L’eccesso si manifesta inizialmente come una sensazione di apertura:
- l’idea che si moltiplica,
- l’intuizione che “tiene insieme tutto”,
- il pensiero che anticipa,
- la percezione di vedere un orizzonte più ampio degli altri.
È una forma di potenza.
Una percezione di intensità cognitiva che dà energia, entusiasmo, sicurezza.
Molti giovani ad alto potenziale descrivono questa fase come un sentimento di “essere vivi dentro”, un’euforia sottile, un movimento continuo che li spinge a immaginare, progettare, collegare.
È un piacere intrinsecamente epistemico: nasce dal gesto di vedere e comprendere più velocemente di quanto si possa verbalizzare (ecco una differnza tra funzionamento visuo spaziale e funzionamento sequenziale). Una sorta di effervescenza mentale che porta con sé un senso di possibilità illimitata.
Ed è il momento in cui la mente generativa “funziona”: esprime al massimo la sua natura.
4.2. La saturazione: quando il troppo diventa pesante
Ma l’espansione non rimane mai pura. A un certo punto, il sistema supera la soglia di equilibrio.
Il numero di elementi in gioco diventa ingestibile; troppe connessioni, troppi stimoli, troppe piste aperte. L’eccesso, da motore, diventa carico.
È il momento in cui il soggetto sente un fremito di fatica:
- non riesce più a seguire la propria velocità;
- sente il pensiero accendersi in più punti contemporaneamente;
- percepisce una tensione interna, quasi un affollamento.
Clinicamente, questo passaggio è evidente: lo sguardo si disperde, il discorso si frammenta, la postura si irrigidisce.
Il soggetto si trova dentro una mente che continua a produrre, anche quando lui non riesce più a reggerla.
Nell’IA generativa, questo è il punto in cui il modello “salta”: aumenta la temperatura interna del sistema, perde coerenza, produce output laterali, deviazioni, rumore.
Nel vivente, la saturazione è la soglia tra il piacere del pensiero e la fatica di contenerlo.
4.3. Il disagio dell’illimitato
Se la saturazione non trova un argine, interno o esterno, si apre lo spazio dell’angoscia.
Non è ansia: è angoscia.
Una differenza sottile ma clinicamente cruciale.
L’ansia ha un oggetto.
L’angoscia è un campo.
È la sensazione che il sistema mentale sia diventato troppo grande per essere abitato. Si perde il controllo, se poi prevale un fare perfezionista, meglio trincerarsi nel passivo.
I ragazzi ad alto potenziale lo descrivono spesso così:
- “Non riesco a spegnere il cervello.”
- “Parto da un punto e arrivo chissà dove.”
- “Mi perdo.”
- “Sento che si apre tutto e non riesco a chiuderlo.”
È il passaggio dall’espansione alla disintegrazione: non più la ricchezza del possibile, ma la paura del caotico.
E questa paura, quando non viene riconosciuta, può manifestarsi come ritiro, blocco, evitamento, irritabilità, confusione apparente, il ritiro nella lettura, nei giochi video …
4.4. Il cedimento dell’ancoraggio
L’angoscia nasce quando la regolazione non riesce a contenere la produzione.
Non è la produzione il problema: è la perdita dell’ancoraggio.
Per i sistemi artificiali, il contenimento è dato dalle istruzioni, dai pesi, dal tuning, dall’architettura. Per il soggetto, l’ancoraggio è dato da:
- una rete di significati stabili,
- un contenitore emotivo,
- un’esperienza di riconoscimento (da parte dell’altro o di sé),
- una capacità narrativa di “dare forma” al troppo
- l’incontro con un Altro costituente
4.5. L’eccesso come luogo di oscillazione
Il vissuto dell’eccesso non è lineare: è oscillatorio.
Si può passare dall’espansione (entusiasmo, vitalità, creatività, curiosità) alla saturazione (tensione, confusione, stanchezza), ritrovare il proprio centro di gravitazione (lasciandoci andare nella lettura, nei giochi video, nel suonare). Qua e là l’angoscià potrà farla da padrona.
Perché l’eccesso è anche questo: un modo di vivere il pensiero che porta con sé un surplus emotivo inevitabile.
4.6. Il ritorno possibile
L’angoscia non è l’ultima scena.
Il pensiero ad alto potenziale, proprio perché generativo, è anche dotato di belle risorse ricostruttive.
Quando trova appigli esterni (relazione, contesto, ritmo) o interni (metacognizione, auto-narrazione, regolazione affettiva), il soggetto può rientrare nell’espansione in forma “abile”, non più caotica.
Forse il ritorno dalla vertigine porterà con sé intuizioni profonde, come se il soggetto avesse visto “troppo” ma avesse trovato un modo per dare parole alla memoria.
4.7. Il vissuto emotivo dell’eccesso: aneddoto
Un aneddoto: quando il pensiero accelera più del corpo
Ricordo un ragazzo, chiamiamolo Filemone, seduto di fronte a me, le mani che tamburellavano sul bordo della sedia. Parlava veloce, troppo veloce persino per lui.
A un certo punto si è fermato, di colpo, come se gli mancasse l’aria.
Mi ha guardato con una sincerità improvvisa e ha detto:
«Io non so più cosa sto dicendo. È come se le idee mi corressero davanti… e io inciampassi dietro.»
Gli dico: ”non credo di capire”.
E lui: “se provo a fermarmi, mi trovo nel vuoto. E se continuo, mi perdo”.
In quelle parole c’era l’euforia del pensiero che si apre, la fatica della mente che non riesce più a trasmetterlo.
Mentre parlava, non descriveva solo il suo stato mentale: descriveva l’esperienza interna dell’eccesso.
Ogni nuova idea che gli nasceva in testa generava altre due idee, poi altre tre, poi un intreccio che si ingarbugliava da solo.
Lui lo viveva nel corpo: un peso nella testa, una tensione nelle spalle, un bisogno di movimento continuo, come se il corpo dovesse proteggersi da un pensiero che non trovava confini.
Un’altra cosa che mi ha colpito è stata questa frase:
«A volte penso che la mia testa sia troppo grande, fisicamente troppo grande. Non in senso intelligente … proprio troppo grande per me.»
4.7.1. Di cosa ci parla il vissuto
Non dell’essere troppo, ma del sentire troppo, dove il pensiero non è più un alleato ma un turbine. Quado il soggetto cerca, a volte inconsapevolmente un ancoraggio esterno, qualcuno che possa dirgli e chiedergli:
“Fermiamoci qui, insieme. Facciamo ordine. Di tutto questo, cosa scegliamo di tenere?” “Quale l’obiettivo, quale il senso che vogliamo proporre in tutto ciò’?”.
4.8. L’incontro con un Altro costituente
L’eccesso di possibilità, l’arborescenza cognitiva e l’overflow mentale del soggetto ad alto potenziale non sono di per sé né patologici né dannosi: diventano rischiosi solo quando mancano punti di riferimento esterni che aiutino a contenere, orientare e dare senso a tutto ciò che emerge.
L’“Altro costituente”, l’adulto, il docente, il compagno, il mentore, non interviene per smorzare il pensiero del giovane, ma per fare da bussola, da filtro, da specchio. Attraverso il dialogo, la guida, l’attenzione condivisa, l’eccesso si trasforma da caos potenziale in progetto creativo, da moltiplicazione incontrollata a flusso regolato.
In altre parole, l’Altro costituisce una condizione che permette alla mente plusdotata di direzionare il proprio “zampillo”, di selezionare percorsi rilevanti, di consolidare intuizioni e trasformare il troppo in potenza utilizzabile. Senza questo incontro, la proliferazione libera, rischia di tradursi in ansia, disorientamento e perdita di senso.
5. La crescita come regolazione dell’abbondanza
L’eccedenza non è un difetto da correggere, né un privilegio da celebrare.
È una condizione di partenza, un materiale grezzo, una potenza indeterminata che cerca una forma.
E la crescita, evolutiva, psicologica, relazionale, è precisamente questo: il processo attraverso cui un eccesso trova misura senza perdere ampiezza.
La mente ad alto potenziale non deve imparare a pensare “meno”, ma a pensare con sé stessa, senza esserne travolta.
E questo implica un lavoro di integrazione molto diverso da quello proposto dalle pedagogie dell’efficienza.
5.1. Dare forma all’apertura
La prima sfida consiste nel trasformare la proliferazione in orientamento.
L’arborescenza cognitiva apre cento piste, ma solo alcune diventano realmente significative.
La psicologia dell’alto potenziale non lavora per restringere le possibilità, bensì per insegnare a scegliere quali piste attraversare e quali lasciar depositare sullo sfondo.
È un’arte più che una tecnica: non si eliminano percorsi, si impara a riconoscere dove la mente desidera realmente andare.
5.2. Costruire continuità
La seconda sfida riguarda la continuità interna.
Senza continuità, l’eccedenza produce frammentazione.
Il compito evolutivo consiste nel collegare ciò che la mente apre, dare un filo a ciò che si moltiplica, trasformare la simultaneità in un tempo del pensiero.
Questo non avviene nella testa, ma nella relazione.
È nello scambio con l’altro, genitore, insegnante, terapeuta, che il soggetto impara a riconoscere:
- cosa vale la pena approfondire,
- cosa può essere rimandato,
- cosa sta emergendo davvero.
La continuità interiore è sempre il risultato di una continuità condivisa.
5.3. Contenere non significa limitare
Il contenimento è spesso frainteso come restrizione.
In realtà è l’esatto contrario:
è la condizione che permette alla creatività di non dissolversi.
Contenere significa:
- dare un ritmo,
- dare un inizio e una fine,
- dare una cornice dentro cui l’espansione può muoversi senza implodere.
Il contenimento non è un muro, è un margine vivente.
5.4. Trasformare l’ansia in orientamento
Quando l’eccesso diventa entropia, l’ansia non è un sintomo da eliminare: è un segnale.
Indica che la produzione ha superato la regolazione, che il possibile ha sopravanzato il reale.
- Il lavoro clinico permette di trasformare quell’ansia in orientamento,
di aiutare il soggetto a distinguere tra il pensiero che espande e il pensiero che disperde. - Sul versante psicopedagogico, l’obiettivo non è “ridurre” il troppo, ma renderlo utilizzabile.
Si tratta di offrire al soggetto strumenti per mettere a terra il proprio funzionamento:
strategie di organizzazione, mappe di priorità, ancoraggi metacognitivi che aiutino a capire come si pensa, non solo cosa si pensa.
Il lavoro psicopedagogico accoglie l’intensità e la trasforma in metodo:
dal flusso alla scelta, dall’attivazione alla direzione, dalla curiosità diffusa all’apprendimento intenzionale. - Il livello pedagogico riguarda invece il contesto: spazi, tempi e modalità dell’insegnamento.
Qui la sfida è costruire un ambiente che non punisca l’eccesso, ma lo contenga in modo generativo.
Significa proporre compiti scalabili, percorsi aperti ma non illimitati, attività che permettano di esercitare il pensiero complesso entro cornici sufficientemente definite.
La pedagogia opera sulla forma: delimita per rendere possibile, struttura per favorire l’esplorazione, offre confini che non chiudono ma sostengono.
5.5. La regolazione come competenza esistenziale
Nel tempo, ciò che all’inizio è un bisogno, qualcuno che tenga la cornice, che delimiti, che offra un ritmo e un orientamento, si anela si trasformi progressivamente in una competenza interna.
Questo passaggio non avviene per semplice maturazione, ma grazie a un processo di interiorizzazione: ciò che prima era relazione, ora diventa funzione; ciò che era sostegno esterno si trasforma in struttura personale.
La persona ad alto potenziale può imparare a leggere il proprio funzionamento, a riconoscere i segnali sottili dell’eccesso: l’irrequietezza che precede il sovraccarico, la tensione che annuncia l’arborescenza incontrollata, il piacere dell’espansione che rischia però di portare allo sfinimento.
E da questa consapevolezza nasce la possibilità di modulare.
Regolare significa poter modificare l’intensità, inserirsi nel proprio processo mentale come un autore che sceglie il respiro della frase: quando allungare, quando sospendere, quando lasciare andare.
Significa anche imparare l’arte del rallentare: come gesto di cura verso la propria mente, non come impoverimento; e quella del selezionare, che non è una riduzione del possibile, ma il modo di permettere l’emersione delle terre più fertili.
In questo percorso il soggetto scopre che il pensiero non è tutto uguale: c’è ciò che nasce da sé, dal proprio desiderio, dalla proprio direzionamento interno, e ciò che nasce dall’arborescenza automatica, dalla proliferazione spontanea che, se non è contenuta, rischia di sovrastare.
Saper distinguere questi due movimenti, direzionamento e arborescenza, è uno dei traguardi più significativi: è il momento in cui la persona inizia a riconoscere un proprio stile cognitivo senza esserne travolta.
È un apprendimento che non riguarda solo la cognizione, ma anche la vita emotiva e relazionale.
La regolazione non è una tecnica, ma una forma di presenza a sé:
– sentire quando si sta andando oltre,
– percepire quando serve un confine,
– accorgersi quando si apre uno spazio fertile,
– concedersi di fare un passo indietro o uno avanti.
È qui che l’eccesso smette di essere una minaccia e diventa una risorsa: una potenza che può essere abitata, scelta, direzionata.
Giovanni Galli, psicologo specializzato in Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione
Tutti i diritti riservati